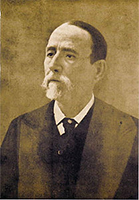Melfi-Napoli, 8-10 agosto.
Mancavo da oltre dieci anni da quella verde e dolce regione di Basilicata che si stende fra il monte Vulture e il gran piano di Puglia. Vi son tornato per due giorni, quando tutti i paesi messi alle falde del Vulture erano in festa per l'inaugurazione della ferrovia Rocchetta-Rionero, quando in quelle campagne, ove di consueto l'occhio riposa nella contemplazione della grande pace campestre, era tutta una festa di sole, di grida e di applausi. Ora che lo stordimento del sole e più ancora quello delle grida e degli applausi son passati, io cerco vanamente di raggruppare le mie impressioni. Ma, chiudendo gli occhi, dinanzi a me non vedo che migliaia di braccia che salutano e migliaia di bocche che applaudono, e vedo ancora la vaporiera rasentare le falde del Vulture, correre sopra ampi viadotti, sprofondarsi in lunghe gallerie.
La parte della Basilicata attraversata dalla ferrovia Rocchetta-Rionero è senza dubbio la più bella e la più ridente della provincia. A poche miglia lontano da Rionero, dopo Atella, cominciano a stendersi a perdita d'occhio le desolate campagne di Avigliano, di Potenza, di San Fele. La linea ferroviaria Potenza- Metaponto, cui si allaccerà la Rocchetta-Rionero, è una delle più monotone e delle più tristi d'Italia.
Il treno corre per intere ore fra colline basse e tristi, fra monti cretacei e incolti, per pianure sonnolente e acquitrinose, ove pascolano mandrie di buoi, che volgono appena la testa a guardare il treno che fugge. Di tanto in tanto si veggono sui monti lontani dei piccoli aggregati di case piccole e nere, accovacciate in alto, come al sicuro dai briganti e dalla malaria.
Invece da Melfi a Rionero il treno corre fra campagne ricche di verdi pampini e di oliveti di un verde assai cupo. La meravigliosa montagna del Vulture, ricca di boschi ombrosi, è coltivata fino alla cima e non ha niente di solenne e di triste. Le piccole città della contrada messe a poca distanza dalla ferrovia sono, se non tutte graziose, tutte abbastanza civili e abbastanza progredite, Rionero ha circa 15 mila abitanti ed è in via di continuo progresso; Rapolla e Barile sono dei villaggi agricoli assai fiorenti, e Melfi è una vera città, ove la vita sociale è molto più larga, molto più serena, molto più comoda che negli altri piccoli centri del Mezzogiorno, travagliati sempre da piccole lotte intestine e divisi da passioni violente e da odii profondi.
Tutti questi paesi alle falde del Vulture sono quasi esclusivamente agricoli. La natura vulcanica del suolo è assai propizia alla cultura della vite e a quella degli olivi, e il grano è coltivato assai largamente nelle basse e malsane pianure dell'Ofanto. Il commercio dei vini, anche dopo che il mercato francese fu chiuso ai vini d'Italia, è assai prospero e fiorente. La causa di questa fortuna dei vini del Vulture va cercata sopra tutto nella ricchezza del loro grado alcoolico e nella loro capacità di resistenza ai lunghi trasporti.
L'industria è però ancora nello stato rudimentale ed è praticata a domicilio con deboli capitali e senza macchine, o con macchine abbastanza primitive. L'influenza delle costruzioni ferroviarie ha senza dubbio giovato a qualche cosa, e sono sorte qua e là delle piccole officine e delle fabbriche di laterizi. Ma sono tentativi isolati, nati portando nel seno il baco roditore, e che assai difficilmente potranno essere il nucleo di un vero sviluppo industriale.
I paesi del Vulture non sono sfuggiti al male che ha colpito la Basilicata e gran parte del Mezzogiorno negli ultimi anni: l'abuso del credito. La concorrenza fra i due maggiori Istituti di credito del Regno, così sciaguratamente tenace, ha per lungo tempo fatto in modo che anche i piccoli coltivatori, i piccoli borghesi, i fittavoli ricorressero frequentemente e largamente al debito cambiario, meno per migliorare e trasformare le loro terre, che per poter spendere con maggiore larghezza. Quindi molte piccole Banche, così dette cooperative, sono già fallite: qualche altra è in via di fallimento. La Banca di Rionero, fallita lo scorso anno con un deficit enorme, ha trascinato nella sua rovina centinaia di depositi di poverissimi contadini. Anche a Melfi i fallimenti dei privati sono stati molti e gravi. Ma, tutto sommato, se il paese ha risentito assai duramente gli effetti di tanta imprevidenza, ha però mostrato e mostra tuttavia di saper resistere con animo virile alla sventura. Ma il colpo è stato durissimo, e le cicatrici del male sono tutt'altro che rimarginate!
La costruzione del tronco Santa Venere-Rionero è riescita difficile e costosa: il resto delle linee Ofantine costerà, forse, proporzionalmente, meno, ma costerà sempre moltissimo. Le naturali asperità del terreno, la costituzione geologica delle montagne, rendono assai costosi e assai difficili i lavori ferroviari. Ora a tanta spesa, a tante difficoltà superate, corrisponderanno in avvenire delle larghe entrate, e lo Stato e la Provincia di Potenza potranno mai rivalersi largamente dei duri sacrifizi sopportati? Ahimè! io so che lo spero, ma so pure che non lo credo.
La costruzione delle Ofantine non è stata punto, né una buona impresa, né tanto meno un buon affare; ma è stata invece un grande atto di civiltà. Costruire quattro tronchi ferroviari, formanti tutti insieme una gran croce, in una regione grande quasi quanto il Belgio, e non solcata ancora che da una sola ferrovia, significava aprire alla civiltà tutta una vasta parte d'Italia, che molti secoli di miseria, di brigantaggio e di sventura avevano resa assai poco capace di progresso e assai refrattaria ai benefizi dell'istruzione obbligatoria.
Questo è stato il desiderio, questa la speranza che han guidati per tanti anni i più ardenti caldeggiatori delle Ofantine, questo era almeno il pensiero di colui che è stato l'apostolo più infaticabile delle ferrovie della valle dell’Ofanto, voglio dire Giustino Fortunato. Per dieci anni Giustino Fortunato non ha parlato, non ha quasi scritto di altro che delle Ofantine; questo spirito purissimo, questo intelletto superiore ha sacrificato gran parte di sé stesso e del suo avvenire politico al desiderio di realizzare il sogno di strappare la sua regione a quella fatalità storica che l'ha finora dominata e di aprire il suo paese all'influsso rigeneratore della civiltà. Sia lode a lui! Mentre egli nel banchetto d'inaugurazione, in un brindisi che parve una lirica, e con voce che mal celava la grande letizia e la grande commozione per l'opera compiuta, esponeva le lotte passate e le speranze nuove, noi eravamo tutti commossi, e ci sentivamo come vinti da una così grande e così vera elevatezza di sentimenti. Pure, ahimè! la grande opera di trasformazione e di civilizzazione che Giustino Fortunato ha così lungamente sognata è tutt'altro che compiuta. E chissà s'egli troverà mai dei compagni e dei continuatori che vogliano e sappiano menarla a termine, se non con pari ingegno, almeno con pari disinteresse e con pari audacia!