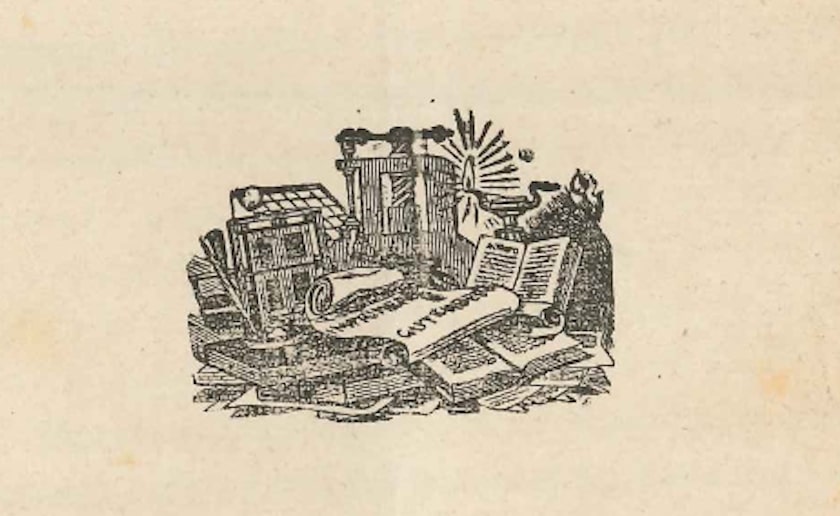L'EVOLUZIONE PEDAGOGICA POSITIVA DAL RINASCIMENTO AI NOSTRI TEMPI
FELICE BILANCIA
Potenza - Tipografia Editrice Garramone a Marchesiello, 1908
La tradizione dei popoli antichi ha fatto giungere insino a noi i costumi primitivi ed i mezzi di educazione che venivano da quei popoli medesimi messi in opera. Mezzi più o meno positivi, tutti però inerenti alla indole, al carattere, alle esigenze degli abitanti, e ci è nota la grandissima differenza che passava fra l'educazione dei figli dell'antico oriente, con quelli dell'antico occidente. Dall'educazione chinese a quella dei greci e dei romani, havvi un distacco oltremodo grande. Quella tutta mistero, tutta fondata su principii religiosi e su superstizioni ridicole; questa invece basata sul reale, sul concreto, sul bello, sul buono, sull'utile pratico.
Quella dei romani specialmente, utilitaristi per eccellenza, era fondata esclusivamente sul concetto fondamentale di allevare uomini virtuosi, integerrimi e nell'istesso tempo altamente pratici, altamente speculativi. Ond'è che ci convinciamo sempre più che l'educazione dei popoli corrisponde sempre ai suoi bisogni. Ma col cadere dell'impero romano, cadde pure il prestigio dei popoli, i quali da padroni e signori, caddero servi vilissimi che non seppero più rialzare la loro potenza: effetti tutti della educazione cambiata che fa crescere le generazioni a beneplacito degli educatori.
Sfasciatosi l'impero romano, rotti gli argini a quell'immensa fiumana di barbari nordici, di educazione non si parlò più, e soltanto alcuni secoli appresso la vediamo far capolino fra le pastoie della scolastica, finchè non risorge a novella vita prima con Dante, Boccaccio, Petrarca e in ultimo col grande Vittorino da Feltre. Qui propriamente può dirsi che incominci l'evoluzione pedagogica positiva che va diretta al suo fine, al suo scopo ultimo.
Nato nel 1378 da poveri genitori, condusse una vita di sacrifici e di abnegazione: tutto erasi dedicato allo insegnamento, alla educazione della gioventù, mirando sempre al triplice scopo, fisico, intellettuale e morale, con prevalenza alla educazione fisica, giusta la massima aristotelica - mens sana in corpore sano.
Epperò conviene confessare che Vittorino da Feltre fu il grande progenitore della odierna scuola pedagogica.
Eminentemente pratico, non scrisse nulla; ma le sue azioni sono bastanti ad immortalarlo.
E con lui la pedagogia in Italia si assopì in un letargo lunghissimo, che si sarebbe detto sonno della morte, se di quando in quando non avesse dato segno di esser viva. E intanto in Germania, Inghilterra, Francia e Spagna avveniva lentamente la grande evoluzione, che ricevette un grande impulso quando, a causa degli abusi della corte pontificia, si sviluppò ed assunse proporzioni gigantesche la riforma religiosa per opera di Lutero. Nato nel 1453, fu frate agostiniano, ma, seguendo l'impulso del generoso cuor suo, volle diradare le tenebre dell'ignoranza dei popoli d'allora, e far conoscere loro, per mezzo dell'istruzione, quanto fossero falsati i principii religiosi di quei tempi. Quindi, mentre cercò di far trionfare le proprie riforme e le sue teorie, raggiunse indirettamente un altro fine non meno importante, quello dell'impulso dell'istruzione popolare; e, dettando norme e regole positive e scrivendo libri scolastici, fu uno dei più potenti coadiutori della moderna pedagogia. Ma siccome egli non si era ancora spogliato delle pastoie della scolastica, non comprese che la lingua materna deve essere la base dell'insegnamento popolare. Onde lasciò a Comenio la gloria di separare la scuola primaria dalla latina.
Ma fra questi due grandi, dei quali l'uno iniziatore e l'altro perfezionatore di medesimi principii, abbiamo Raticchio di Vinster, nato nel 1571, il quale aprì a Comenio la strada alle sue teorie, dando maggiore importanza alla lingua materna che non alle altre lingue antiche, e dettando in pari tempo principii fondamentali che non dissentono guari dalle leggi pedagogiche che furono propugnate in seguito dai sommi pedagogisti, che le svilupparono, le confutarono, le ampliarono, le modificarono, e, per mezzo di tutte queste successive operazioni, ci fecero pervenire quelle norme che regolano le nostre odierne scuole popolari.
Infatti fino da Comenio venne proclamato il metodo intuitivo, naturale, sperimentale; da circa 300 anni si proclamava la legge dell'universalità della convenienza e del diletto; e fin da Comenio si cominciò a intuire lontanamente l'importanza dei lavori manuali nelle scuole popolari; onde tutti questi principii in embrione vennero studiati particolarmente dai successori, in modo che vediamo Fröbel istituire la vera scuola infantile, e dettar norme per i lavori manuali. E quello che adesso credesi un portento della scienza pedagogica moderna, l'idea, cioè, di porre un fondamento psicologico a tutto l' edificio scolastico, è principio preso da Locke e studiato e sviluppato dopo di lui.
L' Inglese - medico qual'era, conosceva pienamente l'uomo in tutte le sue parti fisiche e spirituali, e nel suo libro «Pensieri sull'educazione» pone il fondamento di un completo sistema di educazione in conformità dei principi Comeniani, cioè il nesso fra corpo e spirito, e l'influenza del primo sul secondo. Ond'è che l'educazione fisica acquista per lui una importanza somma ed i principii di Vittorino da Feltre sono da lui richiamati a novella vita. Il nutrimento, il sonno, l'igiene della respirazione e della persona, la ginnastica sono trattati con arte finissima, ed alle sue teorie poco o nulla si è aggiunto oggi giorno. Se non che le condizioni miserande dell'Europa nel 1700, condizioni che andarono sempre peggiorando finchè la rivoluzione della Francia non scosse tutti i popoli, avevano indotto molti generosi filantropi ad aver cura dei poveri; fu allora che Calasanzio , de La Salle, l'accademia di Port-Regal, Franche ed altri molti pensarono alla tutela degli ignorantelli, senza però usare un sistema di educazione positiva.
Ma la corruzione del secolo sdegnò il Ginevrino che levò l'atroce grido del dolore e della miseria dei popoli, proponendosi di riformare la corrotta società con la educazione. Questa, caduta nel fango, volle rialzarla esagerandola e propugnando teorie inattuabili, e quindi i suoi sistemi sono tante utopie come la Repubblica di Platone. Tuttavia egli raggiunse il nobile fine di rialzare al grado di dignità la scienza pedagogica, onde le sue teorie attirarono l'attenzione degli scienziati che le confutarono, le studiarono seriamente, e, seguendo l'esempio dell'ape, riuscirono a estrarre tutto il buono, dando così origine ad una nuova scienza basata sullo studio della natura umana e sui fenomeni psico-fisiologici. Ma se Rousseau ebbe mente di pedagogista, fu appunto perchè propugnò i principii Lockiani. Infatti l'Emilio è un trattato di psicologia e di morale pedagogica, una analisi profonda della natura umana, mediante cui tenta riformare la società pedagogicamente.
Senonchè, impregnato di paradossi e di aforismi, il suo ragionamento procede sovente su di una via sbagliata e ne derivano conseguenze assolutamente errate; ma quando sostiene di allevare il fanciullo secondo natura, oh allora è semplicemente grande e appare in tutto il suo splendore il potente ingegno di che fu dotato. Egli vuole che prima di far conoscere la virtù al fanciullo, gliela si faccia praticare in modo che l'esempio preceda sempre il precetto. Se talvolta ha esagerato, non ha poi arrecato quel male che si crede, perchè, dice Voltaire, è esagerando che sovente si inducono gli altri ad entrare nei giusti limiti.
La società del XVIII secolo aveva bisogno di essere richiamata alla natura ed alle sue leggi immortali, ed alle sue sventure trova un balsamo vivificante in Rousseau. Onde apparisce più evidente la continuità pedagogica fra Locke e Rousseau. Entrambi fondano l'educazione sui sensi, entrambi vogliono il sapere utile, entrambi sono altamente utilitari. Ma il pensiero di un naturalismo astratto doveva trovare un applicatore e lo trovò; lo trovò potente, indefesso in Pestalozzi e Fröbel. Quello fu d'animo proclive al sentimentalismo, perchè di carattere dolce, tutto cuore, tutto amore per il simile, specialmente per il povero: sentimenti questi che lo fecero persistere in quello spirito di filantropia che lo ha guidato per tutta la vita. La seguente epigrafe compendia tutto:
Qui giace Pestalozzi Johann Heinrich; nato a Zurigo il 12 gennaio 1746 - morto a Brugg il 17 febbraio 1827; Salvatore dei popoli a Nehuof; moralizzatore del popolo in Leonardo e Geltrude; padre degli orfani a Stanz; fondatore della nuova scuola popolare a Berthoud e a Münchenbuchsee; educatore dell'umanità a Yverdon ); uomo, cristiano, cittadino; tutto per gli altri nulla per sè. Il suo nome sia benedetto.
E tu, amato Enrico, sarai davvero benedetto, e le future generazioni che per te si troveranno migliorate sotto ogni rapporto, innalzeranno inni di gloria al tuo nome sacrosanto, e vivrai nella mente di tutti i buoni, siccome il rigeneratore vero e stabile di una società corrotta, guasta che era sulla via della dissoluzione.
Le opere sue furono molte, fra cui importantissime: «Come Geltrude educa i suoi figli» e «Leonardo e Geltrude». La forma di romanzo è la preferita, in che egli spiega tutta la sua abilità didattica, e conduce quasi alla perfezione i principi di tutti i suoi antecessori. L'ideale pedagogico è con lui pressochè raggiunto; sintetizza tutto ciò che di buono, di bello e d'utile abbiano potuto dire e fare i sommi pedagogisti da Vittorino da Feltre a lui. Genio eminentemente iniziatore, egli applicò quanto scrisse; solo la poca abilità ad amministrare lo fece apparire inetto a condurre un'istituto. I principi che vengono predicati dalla moderna scuola pedagogica positiva sono appunto quelli del Pestalozzi, perchè mai la natura venne tanto sapientemente imitata e seguita in tutti i suoi svolgimenti, come da Lui.
Pestalozzi stesso confessa di dovere molto a Rousseau, e quindi egli è un vero continuatore del filosofo Ginevrino, ma come questi aggiunse elementi nuovi alle teorie dell'inglese Locke, così il Pestalozzi aggiunse principi nuovi al Rousseau, e in queste nuove creazioni appariscono i caratteri distintivi del Pestalozzi, il quale, a differenza di tutti gli altri, studiò profondamente la natura del bambino, per scrutare le eterne leggi che la governano e ad esse uniformare il sistema educativo corresse molti errori speculativi del Ginevrino, e come lui intese di riformare la società: quello però fondossi tutto sull'astratto; Pestalozzi invece fu tutto pratico, e questo è uno dei suoi maggiori vanti. Egli è continuatore di Comenio, perchè la lingua materna è uno dei grandi pilastri che sorreggono tutto il suo edificio pedagogico; è continuatore di Ratichio e di Lutero perchè ha portato nel campo pratico tutte le loro teorie fondamentali; è infine continuatore di Vittorino da Feltre, perchè tutti i principi pedagogici in embrione che questi aveva rischiarato di un lieve barlume, sono stati illuminati da Pestalozzi con luce abbagliante.
Come corona d'alloro che cinge il capo di prode guerriero, così gli studi pedagogici di Fröbel coronano l'opera rigeneratrice del Pestalozzi che rifulge di un'aureola di luce divina.
Fröbel non ripete il Pestalozzi, ma ne allarga le dottrine e le migliora: alla scuola popolare fa precedere gli asili d'infanzia corredati di metodi e di principi sani, convenienti al fine per cui sono messi in azione. Egli, più che come scrittore di opere pedagogiche, è conosciuto come pedagogista pratico; si trova cioè nelle stesse condizioni di Vittorino da Feltre . Ottimo fu il suo trattato della sfera e conosciuto come quello che è la guida di tutti gli asili Froebelliani; la sfera è il punto di partenza, è la base del suo insegnamento, e con lui termina, si può dire, l'evoluzione pedagogica positiva, poichè tutti gli altri pedagogisti di tutte le nazioni, e ve ne sono pur dei grandi, non fanno altro che applicare o leggermente modificare le teorie pestalozziane o froëbelliane; ma in sostanza le basi, i principi, le fondamenta sono sempre quelli.
Ed ora che abbiamo a volo d'uccello passato in rivista l'evoluzione pedagogica positiva di tutti i tempi e di tutte le nazioni, che cosa abbiamo conosciuto? Quali considerazioni siamo in grado di ricavarne?
La moderna scienza pedagogica, portata all'altezza in cui trovasi presentemente, è, come tutte le altre grandi scoperte scientifiche, il risultato del genio, dell'opera, non di una sola persona, nè di una sola nazione, di una sola epoca, ma di molti e molti geni, del lavoro assiduo di più e più persone, di diverse nazioni e vissute in tutti i tempi.
Il telegrafo, le macchine a vapore, l'idrostatica, la meccanica, la fisiologia animale e vegetale ecc. furono sempre i soggetti di studi profondi degli scienziati di tutte le età, di tutti i popoli: nulla nasce grande, sublime, perfetto: tutto è soggetto alle immutabili leggi della natura;
tutto deve essere graduato; tutto deve procedere con ordine; niuna cosa può sottrarsi a queste leggi universali: quindi possiamo affermare che la scienza pedagogica ha esistito sempre: è nata con l'uomo, o più propriamente con la prima famiglia; e cercando tutti di migliorare il loro stato fisico e spirituale, hanno cercato dei mezzi, finchè pervenuti a noi, col sussidio di quanto si era fatto per l'addietro, abbiamo mezzi pressochè perfetti.
Ma tornando all'evoluzione pedagogica positiva, ora siamo in grado di poter affermare che idea predominante dei pedagogisti che l'hanno propugnata, fu sempre l'educazione per la vita pratica, e non la gretta istruzione teoretica, che fuor della scuola non ha applicazioni, e che si dimentica tanto facilmente al punto di perderla del tutto. Lo stesso Locke John, lo stesso Rousseau, quantunque il primo alquanto più pratico del secondo, ma pur tuttavia entrambi pedagogisti teorici, hanno avuto sempre di mira l'autodidattica dell'allievo, fine assai rilevante, come dice il Compayré, che per raggiungerlo è necessario che l'istruzione sia resa come proprietà inalienabile dell'allievo, sia passata in sangue e se ne serva per i bisogni della vita.
LA FAMIGLIA E LA SCUOLA IN ORDINE ALL'EDUCAZIONE INTELLETTUALE E MORALE DEI FANCIULLI
LETTURA DEL PROFESSORE G. CAPAGUZZI
Direttore della R. Scuola Magistrale di Matera
Matera - Tipografia CONTI, 1880
A chi volesse discorrere con ordine scientifico dell'educazione, sarebbe mestieri prender le mosse dall'educazione fisica, l'importanza della quale non può essere disconosciuta se si consideri l'unione indissolubile nella vita dell'essere umano senziente, intelligente, volitivo.
Di fatto le cure tendenti alla conservazione e al perfezionamento delle forze fisiche sono essenzialmente necessarie alla spirituale umana educazione, alla quale, mancando la sanità e la robustezza del corpo, verrebbe meno il soggetto; lo spirito non troverebbe il suo pronto e zelante ministro, e l'anima stessa parteciperebbe della debolezza, secondo il noto adagio: Mens sana in corpore sano. Tuttavia, siccome il trattare di quella parte di educazione che al corpo si riferisce, spetta particolarmente alla Fisiologia e all' Igiene, ai cui principii deve risalire l'educatore, sia nella famiglia, sia nella scuola, così si è creduto opportuno restringere la tesi alla sola educazione spirituale. Si è stimato poi conveniente accennare relativamente alla scuola, a ciò solo che ella ha di comune colla famiglia, essendo attribuzione esclusivamente scolastica determinare i metodi, i modi, i programmi didattico-educativi.
Il bambino nasce con tutte le facoltà, con le naturali tendenze in principio, in germe, le quali è forza sieno bene sviluppate, perchè producano poi il sapere e la virtù, che non nascono in noi, ma devono essere il necessario risultamento di uno spirito attivo intelligente e libero, il quale sappia differenziare il vero dal falso, il bene dal male. (Girard)
Ma l'esperienza e la ragione ci avvertono che le facoltà e le tendenze dello spirito umano non possono essere lasciate libere nel loro svolgimento e perfezionamento, imperciocchè, scadute dalla perfezione primitiva, sopraffatte dai bassi istinti dell'uomo animale, ingannate dalla fallacia dei sensi, allettate dalle seduzioni, pervertite dai cattivi esempi d'ogni sorta, facilmente prendono una direzione opposta a quella per cui sono date e ne conseguono ignoranza ed il vizio i quali appunto altra sorgente non hanno che l'allontanamento delle facoltà o potenze dello spirito umano dal loro oggetto che è il vero, il bene. Infatti, del pari che nelle piante operano nell'uomo in maniera appropriata le intrinseche forze poste da Dio in questa sua eletta creatura. Ma come la pianta, perchè germogli e cresca e apra i suoi fiori e alleghi e maturi buone frutta, ha bisogno dell'acqua, dell'aria, del sole, e meglio viene e più produce, se la terra è lavorata e governata, e se essa pianta è difesa, curata, e quasi accarezzata dalla mano del diligente contadino o giardiniere, così il fanciullo spiega le sue potenze per interiore virtù, e si ammaestra per ragionamenti ed esperienza propria; ma vuol essere posto in certe favorevoli condizioni esteriori, vuol ricevere dall'educatore, come nutrimento del suo spirito, le verità che egli non può conoscere da se stesso, e per gli esempi, le ammonizioni, le conversazioni, per l'andamento tutto della vita, vuol essere come circondato da un'atmosfera purgata, ove il suo animo respiri, si riscaldi, pigli forza e vigore. - Lambruschini. Ufficio questo della famiglia aiutata dalla società, mediante la scuola. É evidente che quest'opera educativa non può essere iniziata, né proseguita dalla sola scuola: questa sarà sempre quel santuario cui eresse la civiltà con lavorio di secoli, che seppe resistere a prepotente tirannide, a turbinosi sconvolgimenti, ma nella famiglia è la sorgente precipua della forza o debolezza, della libertà o schiavitù, della virtù o del vizio. L'azione della famiglia pertanto deve precedere e preparare il terreno a quella della scuola, imperciocchè l'autorità della famiglia è la precursora di tutte le autorità, è quella che apre loro la via, che dispone lo spirito umano ad onorarle, ad ascoltarle, che lo inizia al loro insegnamento, e in questa guisa è simbolo e ministra delle altre autorità - Lambruschini. E siccome quando il fanciullo entra nella scuola, non cessa per questo di appartenere alla famiglia, nè compiuto il corso scolastico, massime se elementare di cui specialmente qui si tratta, è in età da allontanarsene, ne viene di natural conseguenza che l'azione della famiglia come deve precedere, così deve accompagnare e continuare l'azione educativa della scuola. Di che distintamente si terrà discorso.
La famiglia e massime la madre, deve iniziare il fanciullo all'istruzione e all'educazione morale che verranno poscia relativamente compiute dalla scuola; e a quest'opera educativa domestica è necessario por mano assai prima di quello che ordinariamente si pensi e si faccia. La formazione in fatti dei buoni abiti non è mai precoce, e a questo fine è diretta ogni azione educativa, sebbene varii e di- versi sieno gli stimoli coi quali il bambino, il fanciullo, il giovanetto sono spinti agli atti e alla loro ripetizione e quindi alla formazione degli abiti che, secondo espone il Rayneri (Pedagogica) costituiscono quasi altrettante potenze seconde. Un celebre educatore richiesto da una madre quando potesse incominciare l'educazione della propria figlia di quattro anni, rispondeva: in tal caso sono perduti quattro anni . Tale giudizio è conforme alla teoria educativa esposta dal Rosmini nel - Supremo Principio della Metodica - ove dimostra che il bambino a sei settimane circa, quando cioè nelle vergini sue labbra, spunta il primo riso ingenuo ed affettuoso, è suscettivo di educazione. La madre quindi deve e può compiere il nobile ufficio che la natura le impose. Ma come? Dalle considerazioni generali astratte, è opportuno in tale bisogna discendere alle particolari e concrete per additare alle madri i modi e i mezzi di cui debbono valersi; e metterle in avvertenza contro le viete e pessime consuetudini il cui giogo è ormai tempo di scuotere. Nè certo vuolsi dalle madri esigere la conoscenza e l'applicazione dei metodi migliori per l'insegnamento del leggere e dello scrivere; non è questa l'istruzione che esse debbono impartire ai loro figlioletti, nè quella cui debbansi arrestare le scuole; il leggere, lo scrivere non sono la vera istruzione, imperciocchè se valgono a togliere il numero degli illetterati, non diminuiscono per questo il numero degli ignoranti. Chè anzi in tal caso all'ignoranza si aggiungerebbe un tanto di presunzione e forse di malizia. Uffizio perciò della madre è di suscitare nello spirito della sua creatura i primi pensieri per formarle poscia sulle labbra le prime parole, seguendo in ciò l'istinto naturale materno, che è tutta scienza, quando è tutto amore. Non vuolsi da ciò arguire che le madri non possano essere illuminate e aiutate; chè anzi le speculazioni dei filosofi, veri benefattori dell'umanità, quando applicano alla pratica della vita i risultamenti dei profondi e diuturni loro studi, vengono in loro soccorso. Conobbe infatti il Pestalozzi l'importanza della madre in tale faccenda e scrisse il - Libro per le madri - con cui pose il primo fondamento dell'istruzione intuitiva a vantaggio dell'educazione, seguito nella santa opera dal Rosi, dall' Aporti, dal Fröbel il cui metodo principalmente dovrebbe essere noto alle madri. Nè da questi educatori dissente il Padre Girard il quale fissando l'attenzione della mente sua profonda osservatrice sul modo onde un'affettuosa madre e sagace, secondando la natura, guida il proprio figliuolo, nello sviluppo delle sue facoltà, ne deduce una teoria da tutti applicabile e consiglia le madri a fare ogni giorno più attenti i loro figliuoli ad ogni cosa che veggano, odano, tocchino o facciasi sentire al loro gusto, odorato, udito perchè ottengano essi in tal guisa non solo più viva la percezione distinta degli oggetti esistenti, dopo averli per qualche tempo confusamente percepiti come formanti un oggetto solo producente una percezione visiva unica, complessa, ma nello stesso tempo compiano e ripetano il primo atto dell'intelligenza, fonte necessaria di ogni sapere. Egli insegna che le madri poi mostrino un dopo l'altro ai loro figlioletti gli oggetti sensibili, ne pronuncino e ne facciano ripetere il nome; ne rilevino le qualità concretandole nella parola. Così a poco a poco ai gridi dell'animale si sostituiranno il pianto e il riso dell'uomo; apprenderà il fanciullo il significato dei suoni semplici e articolati e il loro uso in conseguenza del naturale svolgimento del suo pensiero e del linguaggio che sono a vicenda causa ed effetto l'uno dell'altro; seguendo necessariamente l'ordine graduato delle intellezioni, e senza che punto la madre lo tormenti con l'astrazione delle regole: imperciocchè, dice Bernardin de Saint-Pierre, noi non impariamo più a parlare per via delle regole grammaticali che a camminare per via delle leggi dell'equilibrio. È necessario però che in questa proficua attività del fanciullo diretta e sorvegliata dalle madre, sia mantenuta in lui la calma e la serenità dell'anima, sia lasciato tempo al suo spirito di affissarsi sulle nuove cose e soprattutto abbia cura di estendere ragionevolmente il sentimento di benevolenza che è il solo stimolo del suo operare, finchè la ragione non lo illumini o la passione non l'offuschi. Oltre a ciò la madre, contro l'opinione di coloro che vorrebbero nell'educazione infantile una barriera fra il sensibile il soprassensibile, potrà come insegna il Tommaseo, elevare l'animo del suo figliuolo per mezzo dei simboli del mondo fisico alla contemplazione graduale di quelle verità che i sensi non colpiscono, ma a cui l'intelligenza umana aspira e nella loro cognizione piacevolmente si riposa: instillandogli per tal modo fin d'allora nella mente l'idea che l'anima incorruttibile, immortale non è
Simile a bolla che da morta gora
Pullula un tratto e si risolve in nulla .
In tal guisa la madre, senza pretendere trattare di proposito su nulla, parlerà occasionalmente di molte cose e se pur poche saranno le cognizioni dal fanciullo apprese e ritenute, non avrà ragione alcuna per giudicare inefficace l'opera propria, giacchè avrà iniziata l'energia mentale risvegliando nel fanciullo l'attenzione, l'osservazione, l'intelligenza insomma che afferma il vero, la memoria che lo ricorda, l'immaginazione che lo trasforma in tipi ideali; avrà educato il buon senso e il buon gusto. Sul terreno così dissodato la scuola getterà poi i suoi semi attenendosi anch'essa almeno nei primi anni, allo stesso metodo, secondo il quale ogni insegnamento e ogni esercizio educativo delle potenze è coordinato e in certa guisa subordinato all'insegnamento della lingua materna, condotto secondo le leggi che regolano lo sviluppo del pensiero umano. Lavoro questo tanto importante che ha bisogno di essere iniziato dalla madre, seguito dagli asili, perché possa essere relativamente compiuto dalla scuola primaria e popolare che, partendo dalle cognizioni somministrate, come mezzi educativi, in una forma sintetica e senza certi legami, dalla madre e dal maestro nei primi anni di scuola, dovrebbe ripeterle, estenderle, classificarle scientificamente e discendere poi alla loro applicazione nella pratica della vita tenendosi egualmente lontana dal metodo veramente scientifico delle scuole superiori e dall'empirico della madre. In tal modo seguendo il processo delle successive intellezioni e riflessioni, il sapere si forma allargandosi parallelamente come i cerchi successivamente formantisi per sasso gettato, alla superficie di placid'acqua. È certo d'altronde che l'universale delle madri non sarà da tanto, ma riescirà loro men difficile l'astenersi dal disturbare e contrariare il naturale sviluppo al bambino e dal presentargli il falso sotto l'aspetto del vero. Troppo lungo sarebbe enumerare i racconti fantastici, i pregiudizi ingiustificabili, gli errori deliberatamente esposti con cui esse abusano della credulità fanciullesca ponendo con ciò solo un ostacolo, spesso insormontabile, all'apprendimento del vero.
Fin qui dell'educazione intellettuale che il fanciullo deve ricevere in famiglia prima che nella scuola; ma cosa di ben maggior importanza è la prima educazione morale da cui per la successiva formazione di abiti sempre analoghi ai primi, s'informa l'animo del fanciullo e si imprime il carattere determinante la personalità individuale. Nella famiglia pertanto, secondo il Lambruschini, l'anima del fanciullo deve essere piegata alla docilità, all'amore del lavoro, a quell'amore del bene, a quel virginale pudore, a quella fortezza civile che lo armi contro gli assalti dei tentatori e lo renda schivo dei piaceri che sfibrano e istupidiscono e lo innamori dei diletti puri dell'anima casta e tenera "La famiglia deve inculcare la grande massima: quel che è bene prima, poi quel che è utile e piace; deve insegnare a ciascuno di sollevare sopra di se i suoi genitori, al suo livello i suoi simili, l'uomo sopra l'animale, la Divinità sopra tutti, determinando ed imponendo i doveri secondo il vario pregio degli oggetti. Nella famiglia il fanciullo deve apprendere a dominar la tendenza personale per non divenire egoista, a secondare la tendenza sociale per accettare e riconoscere il bene che dagli altri riceve, e farne egli stesso, a seguire la tendenza morale per innamorarsi del vero bene e praticarlo, a coltivare la tendenza religiosa per risalire colla mente e col cuore alla sua prima origine, al suo ultimo fine, in una parola, dev'essere educato il buon cuore .
I mezzi diretti che la madre, come ogni altro educatore, deve usare sono: la parola per eccitare e dirigere, l'autorità particolarmente per correggere. Ma la parola materna non scenderà al cuore dei fanciulli per guidarne la condotta e imprimerne il carattere, se non sarà improntata di tal affetto che stabilisca tra i due cuori quella corrente di simpatia per cui i palpiti dell'uno si confondano in quelli dell'altro, e per effetto della conseguente benevolenza il volere del fanciullo si congiunga e s'immedesimi quasi con quello della madre, finchè insieme colla propria volontà in lui non sia svolto il
«...principio là onde si piglia
Cagion di meritare in noi secondo
Che buoni o rei consigli accoglie e viglia» .
D'ordinario però l'amore delle madri è una tenerezza languida, inetta che fa insolentire perché debole e mostra al fanciullo la propria debolezza. L'amore dev'essere accompagnato da fermezza, e fermezza di tutti i momenti che temperi con certa gravità dei modi la dolcezza delle parole.
Ma, come si è accennato, o per il predominio degli istinti animali sugli umani, di questi sulla ragione, degli affetti sulla volontà, o per l'ignoranza del bene o in fine per la naturale fallacia dello spirito umano, sia essa attribuita, secondo l'opinione dei varii filosofi, alla libertà umana, alla società, alla natura, ad una prima colpa antica, il fanciullo devia dal retto sentiero, non ascolta la parola materna, non è impressionato dall'affetto di lei. Ecco il bisogno della correzione, per mezzo dell'autorità propria dei genitori della quale per legge naturale sono investiti e il cui uso, prima che un diritto è per loro un dovere, dovere che può trovare un certo riscontro in quello di un tutore, cui incombe impedire al pupillo deteriorare in qualsiasi modo o profondere le proprie sostanze. Giova però credere e rammentare anzi tutto che l'autorità, presa in questo senso, è l'ultimo mezzo a cui la madre deve ricorrere, perchè il più difficile a bene usarsi. Prima di correggere bisogna dirigere, ed eccitare. La mancanza di eccitamento e direzione molte volte rende ingiusto e inefficace l'atto correttivo seguito da un grado qualunque di sanzione, senza di che si riduce a semplice consiglio. L'esercizio pertanto di quest'autorità che giuridica s'appella, deve essere opportuno, tranquillo, giusto, fermo; non voglia incatenare la libertà, ma dirigerla colle regole proprie di ogni età, secondo il concetto del Rosmini, (Supremo principio della Metodica) per non andare oltre i limiti del suo ufficio, nè sostituirsi a quella intima direzione, il cui obbligo cresce nel fanciullo, col crescere dell'età e che dev'essere a suo tempo
La buona compagnia che l'uom francheggia
Sotto l'usbergo del sentirsi pura.
Così l'educatore, qualunque egli sia, deve affaticarsi, come epigrammaticamente diceva il Fontauelle, per rendersi inutile. Il considerare nel fanciullo un essere intelligente e libero, avente ragione di fine, sostenga la madre e l'educatore nella difficile impresa: la diversità dell'indole, dell'età, del sesso li consiglierà a esercitare in diversi modi l'autorità. In fatti, col fanciullo tranquillo, ragionevole, amoroso basteranno due parole d'esortazione; col fanciullo ostinato ci vorranno parole più calde, un contegno serio, qualche volta severo; coll'orgoglioso e iracondo una pacifica, ma irremovibile fermezza; il quieto che stagna, dovrà essere obbligato al lavoro gradatamente crescente, il frugolino che troppo s'agita, costretto alla tranquillità, il flemmatico che assonna, spinto all'azione costante, il pusillanime che s'accascia, rialzato nella stima di se stesso, il presuntuoso che si ringalluzza, rintuzzato, il volonteroso che si confonde, rischiarato; insomma per ogni varietà di carattere un savio indirizzo educativo, che non perda però mai di vista il fine vero ed ultimo e che osservi le due leggi principali di educazione l'unità e l'universalità, e la suprema cioè la convenienza.
A sussidio e conferma dell'autorità nell'educazione si adoperano premii ed i castighi i quali più che ovunque riescono efficaci in famiglia, ove si dispone di tutto che interessa il fanciullo, si conosce meglio e il suo carattere, e ciò che a lui piace o dispiace. I premii e i castighi, che costituiscono la sanzione esterna dell'autorità educativa e per essa della legge morale (non potendosi astrattamente dal fanciullo concepire, finchè non sia giunto a tale sviluppo da vedere e da seguire il lume di ragione) vogliono essere considerati quali farmaci utili e anche necessari all'occorrenza.
Quindi la famiglia non deve abusare massimamente dei castighi, ma neppure in modo assoluto rifiutarli; imperciocchè, come nessuno si fa scrupolo di sorreggere con una strappata violenta il proprio bambino che sta per cadere, o di amareggiare le sue labbra con un farmaco che dovrà ridonargli la salute, così nessuno dovrebbe esitare a trarlo dal pericolo della colpa o della ricaduta colla minaccia e col castigo, due mezzi che hanno il valore materiale di quella strappata, di quel farmaco, ma che in sostanza sono l'ultima parola della giustizia che è la ragione delle ragioni, sebbene però debba in educazione ricercarsi che sieno volti all'emenda e all'esempio più che all'espiazione. Potrebbero ora con lungo e minuto ordine classificarsi i castighi, i premii, i modi da tenersi, l'efficacia di ciascuno; basterà però accennare che tanto i castighi, quanto i premii vogliono essere indirizzati a quei sentimenti che nel fanciullo sono dominanti, dati all'unico scopo di promuovere il bene, allontanare il male, preferiti i premii e i castighi naturali, escludendo fra i castighi quelli che, volendo evitare un male, ne producono uno peggiore; e fra i premii quelli che, scambio di promuovere un bene, si volgono in causa di male, come avviene, quando si considera il premio in se stesso e non nella sua relazione col bene operato.
La loro azione vada di mano in mano decrescendo, finchè l'interno compiacimento o rimorso sia il solo premio o castigo cui il fanciullo riceve in conseguenza di una sua buona o mala azione. Questo sarà indizio che nel fanciullo è promulgata la legge morale, che ne vede il rapporto colle proprie azioni, e che per ciò non pone più nel premio o castigo solamente lo stimolo e la ragione finale del suo operare.
La parola materna, l'affetto, l'autorità appartengono, secondo i trattatisti, all'educazione diretta, la quale se non viene rafforzata dall'educazione indiretta, è di un'efficacia dubbia assai, mentre questa senza quella porta i suoi frutti. Primo e più potente mezzo di educazione indiretta, e forse quello a cui si può ridurre tutta l'educazione provvidenziale, è l'esempio che colpisce direttamente i sensi, suscita i sentimenti, coi sentimenti l'affetto, con questo l'azione; che ha tutta la forza del comando e la dolcezza dell'invito ed è considerato dal Rayneri come parte dell'autorità che dicesi di fatto. L'efficacia dell'esempio a confronto della parola è innegabile, essendo essa fondata sulle naturali tendenze del fanciullo alla benevolenza e all'imitazione, e sulla vita dei sensi, che in lui predomina. Perciò nessuna parola, dice il Belgioioso, per quanto saggia, ha valore sul labro di colui che non è pronto a confermarla coi fatti. E il P. Girard non si peritò nell'affermare che, se i modelli tali sempre fossero da essere imitati, il fanciullo camminerebbe tosto sul sentiero del bene e l'educazione, informando i suoi primi pensieri, troverebbe in lui buone abitudini che servirebbero maravigliosamente all'opera sua. E pur troppo è da attribuirsi all'incauto e insano procedere dei genitori se poi l'opera della scuola, per quanto concerne massimamente l'educazione morale, non dà quei frutti che s'avrebbe diritto di esigere, imperciocchè formati gli abiti, questi diventano stimolo della volontà e padroni della libertà. E chi potrà poi vincere la forza dell'abito nel quale anche il senso comune riconosce una seconda natura?
Difatti, quanto difficilmente i fanciulli trovano un buon esempio da imitare, altrettanto raccolgono larga messe di esempi corruttori.
Se i genitori o le persone che avvicinano il fanciullo sono dati ad una vita oziosa, molle, inetta, disordinata, e sono tra loro in discordia, o almeno non si pregiano e non si rispettano come dovrebbero, o nell'educare non hanno mire conformi e conforme volontà, come potrà egli il fanciullo riverire, obbedire chi lo regola e secondare impulsi incerti e contrari? Come il fanciullo prenderà amore alla sobrietà, all'operosità, all'assestatezza, alla concordia? I frivoli discorsi, le più frivole occupazioni, la ricerca di continui e svariati diletti in certe famiglie impediranno al fanciullo di elevarsi poi all'altezza delle gravi cure della casa e della città, delle austere e disinteressate virtù dell'uomo onorato, dell'uomo benefico, dell'uomo patriota e religioso. Le parole sconce o immorali o irriverenti alla divinità soffocano al suo nascere il sentimento morale e religioso e il fanciullo più altra norma non accetta al suo operare che il proprio piacere e utile. Oltre a ciò chi con dolore non osserva la vita civile e politica caduta nell'indifferenza o peggio, il carattere degli individui falsato? Il fanciulletto che sente tutto di imprecare a chi si trova sur un gradino più elevato della società, disprezzare chi si trova più in basso, maledire al lavoro; che vede non obbedite, ma eluse le leggi, non rispettati i legittimi poteri da cui emanano, dileggiatine gli esecutori, come potrà vivere contento nella propria condizione, considerare suoi simili tutti gli uomini, divenire laborioso, obbedire e rispettare le leggi, e i magistrati della patria sua? Nessuno impedirà che il bambino cresca pusillanime, se al più piccolo rovescio di fortuna vede la disperazione nella famiglia, scambio della rassegnazione cristiana e della coraggiosa prudenza di rimediarvi; dissipatore, se vede scialacquare in un dì il guadagno di una settimana; intemperante, se ogni giorno assiste al ributtante spettacolo dell'ubriachezza; improvvido, se i suoi tutto aspettano e vogliono dagli altri; incostante se nulla vede mai condotto a fine; rassegnato alla necessità delle cose, se ode imprecare alla pioggia, alla neve, alla grandine, al freddo, al caldo, all'umidità, alla siccità e non riconoscere tutto ciò come accidenti impossibili ad evitare e che è giuoco forza sopportare pazientemente? Non potrà crescere prudente e canto nelle sue azioni, se di un secreto svelato, s'incolpi la persona cui s'affida più che la propria indiscretezza; di una caduta, il sasso in cui s'inciampa e non la propria sbadataggine; di una ferita, l'arma che la cagionò invece della propria imprudenza. Cose fatte per sè di minima importanza apparente, ma che ne hanno moltissima per la formazione del carattere. Nè sono meno guasti i sentimenti. Il fanciullo ode il precetto: onora il padre e la madre, ma non saprà applicarlo, se vede maltrattati dal padre e dalla madre quelli che loro diedero la vita. Gli sarà inculcato il precetto del perdono, ma poi gli stessi genitori che forse recitano ogni giorno con lui il dimitte nobis debita nostra ecc., sono e si mostrano riboccanti di livore e di odio per la più piccola ingiuria e non anelano ad altro che alla vendetta, e spesso anzi prendono quella di cui i figliuoli non sarebbero capaci. La finzione, l'orgoglio, l' invidia, l'ambizione, in superbia per lui saranno virtù, quando i suoi facciano consistere l'essere nel parere, levino a cielo i propri meriti, si consumino di rabbia pel bene altrui, arrovellino per superare gli altri schiacciandoli, considerino tutti a loro inferiori. Ne valga a discolpa che il fanciullo fuori di casa avrebbe gli stessi cattivi esempi, parocchè, se tutte le famiglie si compenetrassero del grave danno, ciò non avverrebbe, appartenendo ogni individuo ad una famiglia; in secondo luogo l'esempio cattivo dato da chi non è in relazioni intime col fanciullo, nè ha su lui alcuna autorità, può esser volto a buon fine. E quindi da concludersi colle parole di un eccellente educatore italiano: Il fanciullo oda e veda cose biasimeveli, ma è mestiere che le vegga e le oda come biasimevoli, che nulla gliele mostri come usanza trovata da noi e che noi lasceremo così: bisogna farle notare raffrontandole ad altre degne di lode.
All'età di sei anni, ove manchi l'asilo o il giardino d'infanzia, i genitori affidano alla scuola i propri figli e con questo atto delegano, almeno in parte, la loro autorità agli educatori. Da questo momento la scuola, proseguendo l'opera della famiglia, deve intendere, come dice il Rollin, a coltivare l'intelletto dei giovanetti ed a fornirlo di tutte le cognizioni di cui sono capaci alla loro età: dare opera in seguito a rettificare e regolare il cuore per via di principii d'onore e di probità: procacciare finalmente di compiere quello che ebbe abbozzato la famiglia, formando l'uomo morale: compito arduo assai si propone la scuola la quale può e deve molto, ma non può tutto senza l'aiuto della famiglia. È necessario quindi che in questo secondo stadio dell'educazione, genitori e maestri si dieno la mano per preparare un popolo nuovo a questa Italia, un popolo che abbia fede, che non giaccia nel fango, ma coll'occhio rivolto al cielo pensi, lavori ed ami.
Anzi tutto, perchè il fanciullo impari e si educhi, non basta che sia iscritto sui registri scolastici, importa che si presenti a tutte le lezioni; da questo deve cominciare l'opera che la scuole attende dalla famiglia. Curate l'iscrizione e la frequenza, la famiglia secondi scuola o aiutandola od almeno non contrariandola. Primo mezzo di aiutare la scuola è il riconoscerne il valore, il considerarla come un surrogato della famiglia, come un santuario del sapere e della virtù, e non come una custodia o, peggio, relegazione di bambini e fanciulli.
"Nell'insegnamento medesimo aspetta aiuti dalla famiglia la scuola. Il maestro assegna esercizi che sieno materia di studio tranquillo a casa, ma chi veglia, perchè vi si attenda?" (Lambruschini, Istruzione). Non sempre, è vero, anzi di rado, un padre una madre sanno tanto, o possono disporre del tempo necessario per farsi ripetitori ai propri figli, ma tutti e sempre possono non impedire per negligenza, e non turbare per malaccorto contegno, o per mal calcolato interesse distogliere i fanciulli dalle loro occupazioni scolastiche, per assegnargliene altre di un'importanza relativamente minore. Soprattutto conviene che i genitori si mettano in relazione coi maestri, ne ascoltino, abbisognando, i consigli, ne dieno, se sia il caso, non li giudichino importuni o parziali, nè troppo esigenti. Abbiano essi sempre in animo di tenere alta la dignità degli educatori, dei quali debbono avere stima una volta ne facciano, per parecchie ore del giorno, i custodi, i direttori dei propri figli; e a tale proposito il Rayneri nella sua Pedagogica fa le seguenti avvertenze: Nella necessità del buon accordo e dell'armonia che deve regnare fra l'educatore ed i parenti dell'allievo, v'hanno due eccessi egualmente perniciosi all'educazione. Essi provengono o dall'inerzia dei genitori o dalle soverchie pretese che questi o gli istitutori sollevano riguardo alla rispettiva loro ingerenza nell'azione educativa. E primieramente i genitori possono, appena consegnati i figli alla scuola, non curarsi più di loro, oppure pretendere d'ingerirsi ad ogni momento nelle cose d'educazione e d'istruzione, inceppando la libertà dell'educatore: peccano i primi per due gravi motivi: 1 perchè dimenticano il loro dovere di vegliare sulle consuetudini, sui costumi, sui progressi dei figli, 2 perchè per tale negligenza privano gli educatori dei sussidii efficacissimi che la loro autorità potrebbe prestare. Ma peccano pur gravemente i secondi, perchè dimostrano coi loro fatti di non riporre nell'opera dell'educatore quella fiducia che, se fosse veramente demeritata, li obbligherebbe a sottrarre i figliuoli dalle mani di lui. Sono oltre a ciò di grave danno ai figli i quali perdendo quella stima verso l'istitutore, che è la base della sua potenza, rimangono freddi e indifferenti alle sue parole ed ai suoi ordini e ben presto entrano in lotta con lui. Nè meno grave è il danno che all'educazione e al fanciullo deriva da quella barriera che alcuni maestri tentano d'inalzare tra la scuola e la famiglia, imperciocchè con ciò solo si privano dell'aiuto tanto loro necessario, e sono causa del rallentarsi dei vincoli e raffreddarsi degli affetti domestici. Dal che consegue la necessità che la famiglia e la scuola non si trovino mai in collisione, che le due autorità, le quali in sostanza ne costituiscono una sola, si aiutino costantemente, si accordino in modo che il fanciullo non trovi nell'una la natural nemica dell'altra, sempre pronta a contraddirla e abbatterla. Perciò, se obbligo della famiglia si è di coadiuvare la scuola, non meno doveroso per la scuola è rispettare e richiedere il consiglio e l'aiuto della famiglia, e studiare ogni mezzo per impedire quelle dissenzioni che, o per colpa dell'educatore o per ignoranza altrui potessero insorgere, sacrificando, al caso, anche l'amor proprio per impedire che dinanzi agli allievi la dignità ne riceva detrimento.
Nè sembra fuori di proposito l'accennare a questo punto i principali errori in cui cadono gl'insegnanti, e più spesso i parenti, nello stabilire il concetto ed il fine dell'educazione. Errori, da cui il più delle volte dipende la poca armonia tra la famiglia e la scuola e le loro diverse e non di rado contrarie esigenze.
Tali errori traggono origine dallo scambiare i fini prossimi dell'educazione col fine ultimo della medesima (Rayneri Pedagogica) . Alcuni mettono il fine dell'uomo e della educazione nel senso e nel godimento e si oppongono perciò ad ogni lavoro od occupazione del loro figliuolo, la quale stimino non che possa recar danno alla sua salute, ma che gli cagioni noia e lo allontani da ciò che più gli piace. Altri invece non ad altro tendono che a vedere le menti dei propri figliuoli gonfie, secondo l'espressione del Montaigne, di sapere e non piene, per menarne poi vanto; quindi stigmatizzano ogni metodo che alla ragione, non alla memoria si diriga. Vi sono di quelli i quali dalla scuola pretendono pei loro figli, solo quanto può essere esclusivamente ed essenzialmente necessario alla vita materiale particolare di ciascuno; perciò stimano perduto il tempo impiegato nell'istruzione generale, diretta allo sviluppo delle potenze in genere ed in ispecie all'educazione morale. Se questi errori sono nell'animo dell'insegnante, non potrà aspirare al titolo di educatore; se nelle famiglie, è obbligo del maestro tentare di persuadere i genitori che la scuola ha per iscopo ultimo l'educazione completa del fanciullo, cioè la trasformazione delle potenze, per mezzo di atti successivi, in abiti ordinati al loro fine, e al fine vero dell'uomo.
Quando la famiglia ha aiutato la scuola, non ha ancora compiuta l'opera sua. La scuola, massime la scuola primaria od elementare, quale oggi esiste in Italia, riconsegna i figliuoli alla famiglia in un'età che ha bisogno di essere guidata ancora, perchè l'istruzione e l'educazione ricevuta trovino una conferma e un'applicazione nella vita e se ne ritraggano quei vantaggi morali e materiali che si ha diritto di esigere. Quindi dopo la scuola continua l'opera educativa famigliare. Il metodo accennato per l'educazione dei bambini in famiglia, serve, e più efficacemente, pei fanciulli e pei giovanetti nei quali l'età e la scuola hanno sviluppato le naturali potenze; e la ragione e la libera volontà hanno cominciato a spiegare la loro azione. Non fallirà per tanto quel genitore che ancor per qualche tempo userà, nelle dovute proporzioni, quei mezzi educativi, che adottava, quando il figliuolo era bambino. A questi però si aggiunge una cura ben grave. I giovinetti che escono dalle scuole elementari, devono scegliere un indirizzo speciale al quale intendere con tutte le loro forze per procacciarsi nella società una posizione, devono insomma compiere il primo atto che li condurrà alla scelta dello stato.
Il savio genitore che per la continua e domestica convivenza col proprio figlio, ne avrà attentamente osservato il carattere, le inclinazioni, le attitudini, temperamento, difficilmente sbaglierà nel guidarlo alla scelta, e ciò tanto più se il consiglio del sagace educatore non gli farà difetto. Ma in cosa di tanta importanza, da cui dipende l'avvenire dell'individuo, non solo, ma il benessere e la pace della famiglia, della società, il genitore non deve lasciarsi guidare da falso orgoglio, nè da abuso della paterna autorità. È necessario che egli tenga conto della propria condizione, della ragionevole volontà del figlio, per non dover pentirsi, troppo tardi, di aver contribuito ad aumentare il numero, veramente non piccolo, degli inetti o dei malcontenti. Le vocazioni devono essere dai padri rispettate e secondate, imperciocchè, come dice il poeta:
Natura
Non patitur cunctos ad eandem currere metam,
Sed varias iubet ire vias, variosque labore
Suscipere, ut vario cultu sit pulchrior orbis.
Dalla considerazione dell'importanza di questo momento della vita umana, nasce il dubbio se la scuola primaria elementare italiana sia ordinata o almeno condotta in modo da estrinsecare le vocazioni e le attitudini individuali dei fanciulli per indirizzarli o ad altro mestiere, e se la biforcazione degli studi in classici e tecnici sia opportuna immediatamente dopo la scuola elementare!
Sebbene principio dell'educazione sia l'autorità sarebbe però grave errore il supporre che senza lo spontaneo e affettivo in prima e poi libero concorso degli allievi, e la famiglia e la scuola potessero vedere coronata di risultamento felice l'opera loro. E necessario perciò che i figli corrispondano alle cure affettuose, instancabili di previdenti genitori e di zelanti educatori, e tanto più quanto maggiormente sono cresciuti negli anni. L'educazione li considera come esseri intelligenti e liberi, bisognosi dell'altrui aiuto e soggetti a fuorviare dal retto sentiero, e colla parola, coll'esempio coll'autorità tenta ogni via per istruirli, educarli eccitandoli, dirigendoli, correggendoli. È dunque mestieri sieno, massime i più grandicelli, fermamente convinti non volere l'autorità altrui opporsi all'esercizio della libertà che Dio diede ad ognuno e di cui canta il poeta:
Libertà vo cercando, che è si cara
Come sa chi per leita rifiuta
ma sibbene ammaestrarli a rettamente usarla, a francarli coll'educazione dalla schiavitù dei mali esempi, dei pregiudizi, degli errori, delle cieche passioni che realmente incatenano la loro libertà, e metterli in condizione di rettamente usarne nella conoscenza, nell'amore nella pratica del vero, del bello, del bene morale.