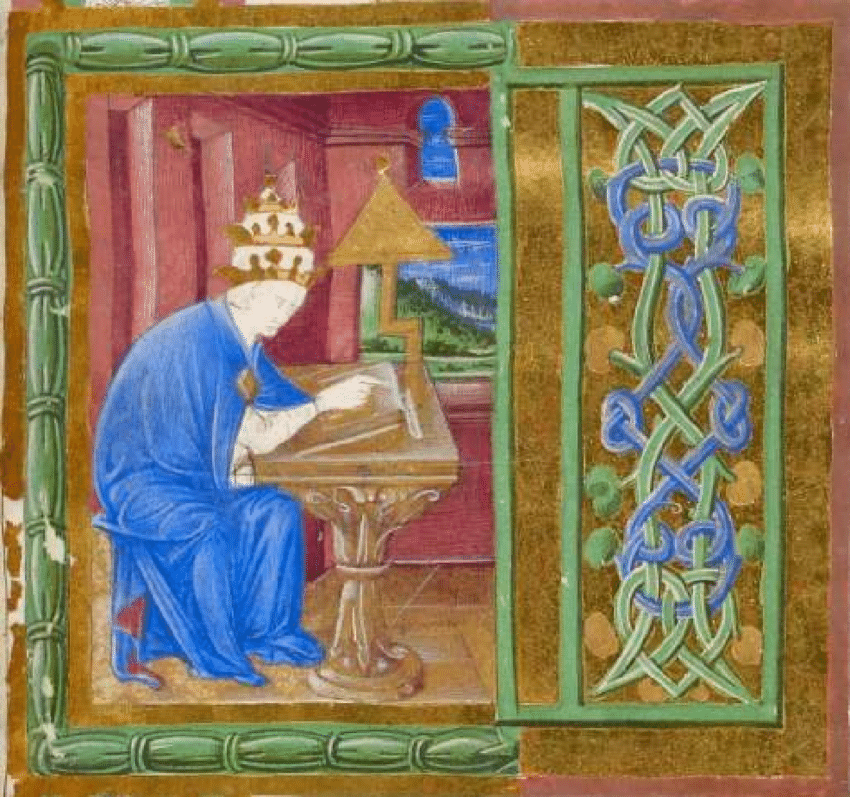
Commento di Enea Silvio Piccolomini agli Alfonsi regis dicta aut facta memoratu digna di Antonio Panormita
Nota al testo
Nota al testo
La presente edizione riproduce, migliorandola in qualche punto, l’edizione già fornita in appendice all’edizione critica degli Alfonsi regis dicta aut facta memoratu digna (Panhormita 2024). Non si tratta di un’edizione critica, ma di servizio, pur se attentamente vigilata, che ha scopo prevalentemente divulgativo e didattico, tanto più che offre per la prima volta una traduzione italiana.
Il testo è strutturato in forma di epistola che inizia con una sezione nuncupatoria; prosegue con un commento puntuale ai vari capitoli dell’opera del Panormita; termina con una conclusio, che include anche la datatio, che costituisce un sicuro terminus ante quem per la compilazione: Napoli, 22 aprile 1456.
Per quanto attiene all’organizzazione dell’edizione si specifica che il testo è stato stabilito partendo dalla collazione dei tre manoscritti che formano il gruppo β1 definito in base alla recensio dell’opera del Panormita. Attestando, plausibilmente, una redazione più antica (Delle Donne 2023), inviata effettivamente al Panormita e poi emendata dall’autore, sono questi (si usano le sigle definite in Panhormita 2024, al quale si rimanda anche per la descrizione e la bibliografia):
F2 – Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plutei, 90 sup. 45, foll. 61r-109r;
P2 – Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal. lat. 959, foll. 41v-73r;
PR1 - Praha, Narodni Muzeum Knihovny, c 31 (k 44), ff. 73r-121v.
Si tratta dei tre manoscritti più antichi che contengono oltre al Commento del Piccolomini anche l’opera del Panormita. In particolare, la datazione del ms. PR1 può essere piuttosto precisa, perché al fol. 201v si legge: «Comperatus est libellus iste in studio Wiennensi per venerabilem M. Leonem Egr. de Perchnis, tunc decanum facultatis arcium secunda vice, anno Domini 1458 ante festum sancti Barptolomei apostoli». Questa informazione, che indica la data del 23 agosto 1458 come quella dell’acquisto del ms. a Vienna, appare particolarmente significativa, se consideriamo che l’opera del Piccolomini è datata 22 aprile 1456. Poco utile, invece, è l’indicazione «ex Neapoli XX iunii» che si trova nel ms. P2 al termine del Triumphus, fol. 60v.
Rispetto alle antiche edizioni a stampa (generalmente molto scorrette), il testo qui costituito risulta, a tratti, molto diverso: in particolare, spicca l’aggiunta, nel ramo β1, dei parr. II 11, 3-5, che contengono una sorta di novelletta di carattere bertoldiano, forse successivamente censurata dallo stesso autore.
Non ci è parso il caso di segnalare in apparato né le lectiones singulares dei mss. usati, né le divergenze con il testo a stampa, anche in considerazione del fatto che a un’edizione critica più completa, basata su tutti i testimoni, stanno lavorando per i «Monumenta Germaniae Historica» Giuseppe Marcellino e Claudia Märtl.
Solo una fascia di apparato è stata approntata, per identificare le citazioni esplicite. Il testo è stato suddiviso in capitoli e paragrafi, cercando di rispettare, nei limiti del possibile, le indicazioni dei codici. I capitoli sono stati numerati in maniera tale da rimanere in linea con la numerazione assegnata a quelli dell’opera del Panormita.
Quanto ai criteri ortografici, si è operata una cauta normalizzazione, seguendo quelli adottati nell’edizione degli Alfonsi regis dicta aut facta memoratu digna (Panhormita 2024). In caso di selectio, in via generale si è preferito dare la preferenza alle forme adottate dal ms. F2; in qualche caso, per piccole cose (come, ad es., al cap. IV 3, 3: «id concilium» invece di «ad concilium») si è intervenuti per correggere un errore che è stato ritenuto d’archetipo.