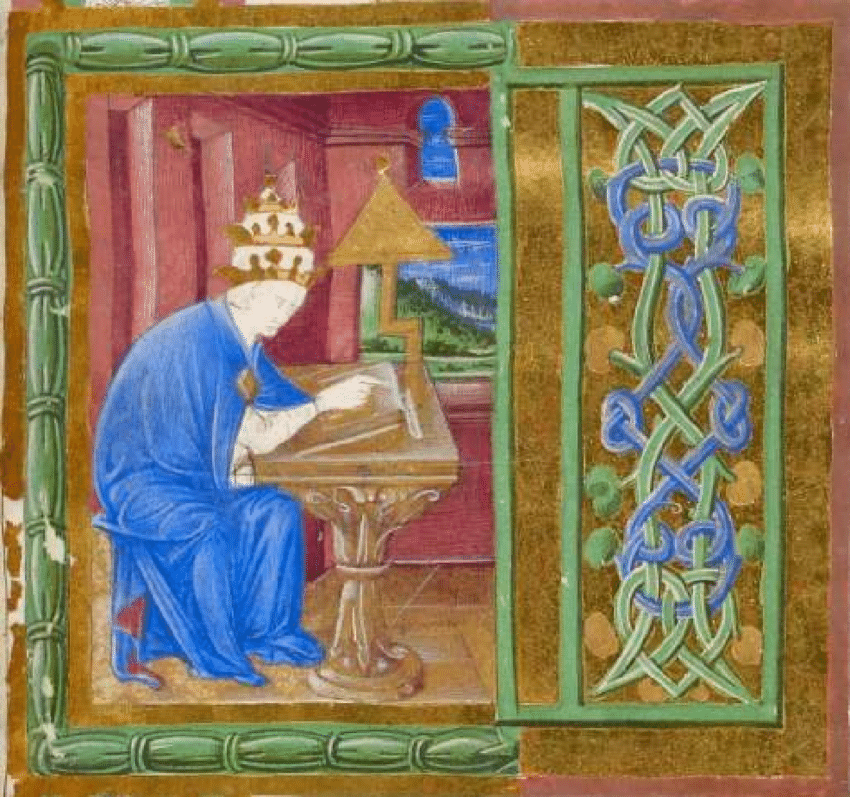
Commento di Enea Silvio Piccolomini agli Alfonsi regis dicta aut facta memoratu digna di Antonio Panormita
date
1456-04-22
title
Enea Silvio vescovo di Siena - Traduzione del Commentario - Libro I
teibody
Sul proemio del primo libro
[1] Alfonso è tanto più grande di Socrate, quanto un Romano
è considerato più austero di un Greco, e quanto è più difficile che i re si
dedichino alla filosofia rispetto agli uomini privati.
Sul cap. 1
[1] Anche i Senesi pregano questo nuovo Ercole di aiutarli,
ai quali è tanto più giusto portare soccorso, quanto più indegnamente sono
oppressi. Perché se il re è solito soccorrere quelli che sono in difficoltà
anche con suo pericolo, certamente non abbandonerà i Senesi, ai quali può dare
protezione e pace anche con una sola parola.
Sul cap. 2
[1] In Inghilterra, che una volta era chiamata Britannia, a
quelli che vengono scoperti mentre si uniscono a donne fuori dal matrimonio, per
comando di un sacerdote, viene ordinato di partecipare a una processione di
clero e di popolo in un giorno di festa e, tenendo addosso solo le mutande, di
girare nudi attorno alla chiesa portando in mano un cero acceso. Se qualcuno ha
vergogna della pena, la sostituisce pagando una multa. [2]
Un tale Manno di Firenze, che spesso era sfuggito alla pena pagando la multa,
colto di nuovo in flagrante decise di sottoporvisi invece di sborsare denaro. Il
giorno stabilito, giunse alla chiesa avvolto da un lungo mantello, e toltoselo
in mezzo alla folla di uomini e donne, rimase completamente nudo. Al sacerdote
che, indignato, gli ordinava di mettersi le mutande, «Neanche per sogno», disse,
«dal momento che è proprio a queste pudende peccaminose che bisogna infliggere
la punizione!».
Sul cap. 3
[1] Baldassarre Cossa, il quale, giunto al pontificato,
prese il nome di Giovanni XXIII, poiché era troppo spesso lodato smisuratamente,
disse: «Sebbene sappia che sono false le cose assai belle che si dicono di me,
tuttavia mi fa piacere sentirle».
Sul cap. 4
[1] Sono savi, a mio giudizio, coloro i quali, dopo aver
ricevuto un beneficio anche piccolo, dicono addio alla curia. Mostrano infatti
che il loro animo si è appagato, e si sottraggono al pericolo che spesso incombe
sui cortigiani, i quali, come maiali messi all’ingrasso, vengono uccisi per la
cena del signore. [2] Gli altri che, pur avendo raggiunto
grandi ricchezze, rimangono presso i re, non lo fanno per rendergli grazie, ma o
non vogliono andarsene da un posto sicuro, o mostrano che per loro nulla è
abbastanza.
Sul cap. 5
[1] Se i Goti e i Longobardi avessero avuto tali re, non
lamenteremmo né le corruzioni di Livio, né i danni degli altri autori.
Sul cap. 6
[1] Mentre seguivo Alfonso da Baia a Pozzuoli, e conversava
con me di letteratura, disse d’aver letto il libro di Agostino sulla città di
Dio tradotto dal latino in francese, nel proemio del quale vi è scritto: «Un re
illetterato non è che un asino coronato». E affermò che anch’egli era dello
stesso avviso.
Sul cap. 7
[1] Di pari prudenza, come mi sembra, dà prova Alfonso nei
confronti di Giacomo figlio di Niccolò Piccinino. Quando lo incontra da amico,
si guarda da lui come un nemico.
Sul cap. 8
[1] Ritengo che le arpie fossero moltissime. Non ho visto
infatti nessuna curia priva di questi uccelli.
Sul cap. 9
[1] Dopo aver intrapreso ciò che è giusto, conviene che il
re mostri un animo invincibile, e che vinca resistendo alla fortuna. Ma quando
ogni sforzo è vano, è preferibile esser vinti che vincere.
Sul cap. 10
[1] Il Girolamo eretico, di cui Aurispa maggiore discute
con il re, intendo che sia quel Boemo che fu mandato al rogo a Costanza, poiché
aveva un atteggiamento empio verso la religione. Aggiungi, se è opportuno, la
patria di Girolamo, perché non sia ignoto ai posteri ciò che noi conosciamo.
Sul cap. 11
[1] Venceslao re di Boemia, fratello di Sigismondo, figlio
ed erede di Carlo IV imperatore dei Romani, irritato da una parola di un suo
ministro, alzandosi dalla tavola, afferrato un pugnale lo uccise anche se era un
amico. [2] Alessandro il Macedone, dopo aver scagliato il
giavellotto contro Clito, con la morte di un uomo a lui carissimo placò la sua
ira, ma mostrò di non aver placato se stesso col pentimento per l’accaduto. [3] Migliore di entrambi Alfonso che, al primo scatto d’ira
ha ceduto come uomo, ma in un secondo momento ha vinto la parte razionale, e i
suoi piccoli, come dice il salmista, li ha scagliati sulla roccia.
Sul cap. 12
[1] L’imperatore Sigismondo diede uno schiaffo a un
creditore bavarese che lo insultava, ma, subito preso dal pentimento, pagò tutto
il debito. [2] Il re fu più mite dell’imperatore, ma forse
la mitezza del re nei confronti di questo cavaliere non fu pari all’ira salutare
dell’imperatore nei confronti del bavarese.
Sul cap. 13
[1] Se Alfonso fosse illetterato, gli sarebbe lecito
durante la cena, come un asino coronato, cercare quiete. Ma è giusto che un re
dotto non abbia nessun momento di riposo, tranne quello che richiede il
sonno.
Sul cap. 14
[1] Cosa può fare Alfonso per suoi sudditi, dal momento che
è pietoso anche verso i nemici?
Sul cap. 15
[1] Certamente basterebbe quest’unica cosa a rendere il
misericorde re prossimo a Dio grande e onnipotente. Infatti, quando il re
detesta una vittoria, c’è da ritenere che sia stata ottenuta con azioni turpi e
crudeli; né egli può venire in soccorso di coloro che in guerra commettono ogni
tipo di scelleratezza.
Sul cap. 16
[1] Mentre a Napoli, in Castel Nuovo, discutevamo sulla
pace della Toscana e sull’ipotesi di inviare Piccinino in Albania in quei
giorni, vedemmo quanto il re fosse esperto conoscitore di Tito Livio, che spesso
citò a insegnamento, poiché diceva che bisogna fare attenzione sin dall’inizio a
non incorrere nell’avversa fortuna. Come si legge infatti in Tito Livio, il
presagio della fine è solito presentarsi sin dall’inizio.
Sul cap. 17
[1] Motto proverbiale dell’imperatore Sigismondo fu che non
sa regnare chi non sa simulare. La vera ragione non approva che il re nasconda
né il volto, né la mente con la menzogna.
Sul cap. 18
[1] Sappiamo che il re si comporta con simile liberalità
nei confronti dei preti poveri, che mettono al primo posto il culto di Dio.
Sul cap. 19
[1] Al conte Federico di Celje, che uccise la moglie per
amore d’una concubina, e poi, dopo aver trascorso tra le prostitute una vita
turpe, è morto un anno fa, uno tra i suoi amici più cari disse: «Già hai più di
novant’anni, e ti concedi al piacere più che se fossi un adolescente. Orsù,
sappi che devi pur morire, pensa alla tomba». [2] E
Federico gli rispose: «Certamente. Ho deciso infatti che dovrà essere scolpito
quest’epigramma sul marmo della tomba: “Questa è la mia porta per gli inferi”.
Cosa troverò lì non lo so. So cosa ho lasciato: ho avuto in abbondanza ogni
bene, di cui non porto nulla con me, né ciò che ho bevuto, né ciò che ho
mangiato, né ciò che il piacere inesauribile ha consumato». [3] «Allora – disse l’amico – tu ricordi che l’epitaffio di
Sardanapalo, secondo ciò che dice Aristotele, bisognava scriverlo non sulla
tomba d’un uomo, ma d’un bue».
Sul cap. 20
[1] Tra i duchi d’Oltralpe ne abbiamo conosciuto uno, che
concedeva facile accoglienza a tutti quelli che ogni giorno venivano, non per
desiderio di dire legge o di amministrare la giustizia, ma per tenere per sé i
doni che venivano portati ai curiali. E non si vergognava di toglier di mano ai
poveri tre o anche due monete, che si chiamano boemicali.
Sul cap. 21
[1] L’Etruria non è inferiore all’agro picentino né per la
bellezza dei campi, né la per virtù degli uomini. Ma ora è devastata: non
abbiamo bisogno del pianto del re, ma di quella volontà che, a quanto dici, ebbe
verso gli abitanti di Sorrento, poiché è potente in pace e in guerra.
Sul cap. 22
[1] Desidererei o che il re sappia tutto senza l’aiuto di
altri, come Alfonso, o che sia a tal punto stupido che, come in catene, venga
dominato dal volere dei consiglieri.
Sul cap. 23
[1] L’imperatore Federico a Vienna e a Neuhaus in Austria
ristrutturò in modo mirabile i castelli e anche Sigismondo lo ha fatto a Buda.
[2] Quanto al resto constato che Alfonso ha superato
tutte le opere nuove e antiche, e ritengo che la reggia di Dario non possa esser
paragonata al castello di Napoli.
Sul cap. 24
[1] I Franchi rasarono i capelli al re, che era
riconoscibile solo per la porpora e il diadema. Chiuso il fannullone in un
monastero, per autorità di papa Zaccaria, lo sostituirono con Pipino, che non
una veste aurea, ma una rispettata moderazione e l’autorità avevano reso degno
del supremo potere regio.
Sul cap. 25
[1] Il re, facendosi aiutante di un asinaio, si conciliò il
favore di alcuni popoli della Campania. Ma, se porterà aiuto ai Senesi e darà
pace alla Toscana oppressa, sarà chiamato protettore e padre sia di quella
provincia sia di tutte le città d’Italia.
Sul cap. 26
[1] È necessario che si tema sempre chi è stato sottomesso
con la ferocia e la crudeltà; resterà costantemente fedele chi si sarà reso
amico con la pietà e la misericordia.
Sul cap. 27
[1] Ugo da Siena, che il nostro tempo ha ritenuto sommo tra
i medici, ebbe una moglie chiamata Ladia Sozzini, di grande virtù, ma poca
bellezza. Poiché era brutta, Ugo era solito chiamarla buona, e avrebbe preferito
esser privato di ogni bene piuttosto che della moglie. [2]
Dunque, può essere amata una donna brutta ma non una cattiva. La moglie di
Tripponio, forse, non ebbe né la soavità dei costumi, né la bellezza.
Sul cap. 28
[1] Il re, che si era armato per una giusta guerra per
condurre l’esercito contro i Fiorentini e i Veneziani, concesse la pace agli
ambasciatori dei nemici che gli venivano incontro nel territorio dei Peligni,
dichiarandosi vinti. I Senesi, però, si dichiarano vinti ancora prima che il re
prenda le armi, e gettandosi ai suoi piedi chiedono grazia. [2] Il re è certamente tanto più glorioso per costoro che per coloro
ai quali ha concesso benevolenza, quanto i Veneziani e i Fiorentini sono più
potenti dei Senesi. Infatti a quelli può sembrare che la pace sia stata concessa
per il fatto che il re si era pentito dell’impresa iniziata, come disperasse di
vincere su città grandi e ricche. Nessuno dubiterà, invece, che la pace sia
stata concessa al popolo di Siena dalla clemenza del re.
Sul cap. 29
[1] Anche al Piccinino forse sarà risultata cosa assai dura
concedere la pace ai Senesi, a lui che cerca per sé ricchezze e gloria a danno
di un mitissimo popolo. Ma non sarebbero mancati alla sua virtù né l’occasione
né l’onore, se si fosse comportato in maniera più modesta e si fosse affidato al
comando del re.
Sul cap. 30
[1] Ai primogeniti dei re, che sono destinati a diventare
re, non a caso viene affidato il governo di gente di tal fatta. Una volta che
avranno sperimentato le stoltezze dei Calabresi, infatti, e avranno imparato a
sopportarle, facilmente tollereranno i costumi degli altri popoli.
Sul cap. 31
[1] La domanda di Alfonso d’Avalos ha avuto risposta
corretta. Ma poteva anche chiedere ancora: «Se l’animo desidera Dio come sua
sede naturale, perché tende tanto malvolentieri a ciò cui desidera arrivare,
specialmente dal momento che non sappiamo servirci di questo bene in
terra?».
Sul cap. 32
[1] Mentre cenavo da Giuliano Cesarini, cardinale di
Sant’Angelo, uomo dottissimo e integerrimo, a Favianis sul Danubio, città che
oggi ha il nome di Vienna, e stavamo lungamente discutendo del concilio di
Basilea, allora, mentre cenavamo, ci accorgemmo che la terra si muoveva.
Johannes Freund [?], ambasciatore renano, che era con noi, diceva che bisognava
alzarsi da tavola e andare in uno spazio aperto. [2]
Giuliano, allora, disse: «State tranquilli, amici: abbiamo parlato del concilio
di Basilea, che ha fatto tremare tutta la Chiesa, ma non l’ha distrutta. Allo
stesso modo neppure questo terremoto ci può spaventare».
Sul cap. 33
[1] Kaspar Schlick, che fu cancelliere di tre imperatori,
affermava di desiderare che tutti i re per un giorno almeno fossero privati cittadini
e poveri: infatti, non ha abbastanza commiserazione chi non è mai stato misero
Sul cap. 34
[1] È molto più grande la gloria se si lascia in vita il
nemico invece di ucciderlo, e tanto più glorioso è il trionfo, quanto più
numerosi sono i nemici risparmiati.
Sul cap. 35
[1] Apprendiamo dall’imperatore Federico che quei
festeggiamenti furono assai fastosi, e che si svolsero in sua presenza durante
la Settimana Santa, due anni dopo il Giubileo. [2] Anche
noi abbiamo visto rappresentazioni, che i Francesi chiamano “mascherate”,
straordinarie e che non hanno uguali, a Losanna, città che si trova vicino al
lago Lemano.
Sul cap. 36
[1] Alessandro assunse senza timore il farmaco preparato
dal medico Filippo, che Antipatro aveva scritto fosse stato corrotto dal denaro
dei Persiani. Entrambi i medici, quello di professione e questo di nome, erano
ritenuti sospetti.
Sul cap. 37
[1] Poiché alcuni lanciavano parole oltraggiose contro
l’imperatore Federico III, a quanto ricordano coloro che erano a corte, Federico
disse: «Forse ignorate che i principi sono esposti come bersagli alle frecce? I
fulmini colpiscono le torri più alte e non toccano le case più basse. Ma a noi
va bene, se veniamo bersagliati solo dalle parole».
Sul cap. 38
[1] Kaspar Schlick biasimava dinanzi all’imperatore
Federico la vita degli ipocriti, e diceva che avrebbe voluto andarsene un giorno
in luoghi privi di quei nefandi uomini. [2] A lui Federico
disse: «Allora ti tocca andare oltre i Sarmati e l’oceano glaciale. Ma, quando
sarai giunto lì, il luogo non sarà del tutto privo di ipocrisia, se soltanto
anche tu sei un uomo e non un dio. Tra i mortali infatti non c’è nessuno in
nessun luogo che non sia simulatore e falso».
Sul cap. 39
[1] Un tale Antonio, siciliano, professo dell’ordine di san
Domenico, tenne un’omelia di fronte ad Alfonso durante la celebrazione in coena Domini; si mostrò al re come se si compiacesse
di quel fatto, e quasi come se bisbigliasse dal pulpito, e propose alcune nuove
questioncelle sul sacramento dell’eucarestia. [2] A lui il
re disse: «Padre, io ti chiedo: un tale aprì un vaso d’oro in cui il mese prima
aveva riposto l’eucarestia, e non vi trovò nulla se non un vermetto. [3] Dall’oro, che era mondissimo e purissimo, e sigillato
da ogni lato, non sarebbe potuto nascere un verme, neanche per un caso fortuito
che lì potesse presentarsi. Il verme quindi s’era prodotto dal corpo di Cristo;
ma dalla sostanza di Dio cos’altro potrebbe nascere se non Dio stesso? Dio
dunque è un verme. Cosa rispondi a queste cose?». [4] Il
monaco rimase in silenzio. Noi che eravamo nella cerchia degli uditori, capimmo
che il re non aveva certo frequentato invano le scuole teologiche.
Sul cap. 40
[1] L’Italia, che gode nei cambiamenti e non ha nulla di
stabile, non ha più alcuna traccia dell’antico regno, e facilmente potresti
veder diventare re chi prima era servo. [2] Il nostro tempo
ha venerato Piccinino, figlio di un macellaio, quasi come un re. Concediamogli
pure la conoscenza dell’arte militare, ma, a mio parere, rispetto a chi
preferisce fuggire o esser preso piuttosto che morire, bisogna ritenere ottimi
comandanti in guerra quelli come Giovanni Hunyadi per gli Ungheresi, Scanderbeg
per gli Albanesi, Pogebraccio per i Boemi, Alberto margravio di Brandeburgo per
i Tedeschi, i quali, benché abbiano vinto spesso i nemici, mai ottennero una
vittoria senza perdite. [3] Ma i soldati italiani sembrano
dei mercanti, al punto che darebbero cavalli e armi per fuggire liberi, e
appunto incassano paghe come mercanti. [4] Dunque, è vera
la sentenza del re:
[5] Ma potresti trovare più spesso un Ercole nato da un
macellaio, che un Piccinino nato da un Ercole.
Sul cap. 41
[1] Enrico, conte di Gorizia, fu grande e ottimo bevitore.
Egli ebbe dalla moglie ungherese, donna nobile e prudente, due figli, che prima
della fine dell’infanzia tenne con sé nella sua camera nuziale, ed era solito
spesso chiamarli nel mezzo della notte mentre dormivano, e chieder loro se
avessero sete. [2] E poiché quelli non gli rispondevano
(infatti erano immersi in un sonno profondo), si alzava e beveva vino; ma
siccome quelli lo rifiutavano e lo risputavano, rivolgendosi alla moglie disse:
«Li hai concepiti da un altro uomo, meretrice: non sono di certo figli miei,
questi che dormono tutta la notte senza aver sete».
[3] Leonard Felsech, nobile cavaliere, quando giunse nella
città di Lipsia, in cui i Sassoni apprendono le arti liberali, e suo cugino, che
allora era lì per studio, gli chiese perché si trovasse lì e per quanto tempo,
un uomo che lo conosceva ed era suo assistente, disse: «Il tuo amico si comporta
benissimo: infatti tra tutti gli studenti, e ne siamo millecinquecento, egli
solo ottiene la vittoria nel bere». E l’uomo non ritenne di aver detto cose
sgradite. È infatti usanza dei Sassoni, quando qualcuno arriva, porre al primo
posto chi beve di più, e chiamano trincare questo divertimento.
[4] Ulderico di Neuhaus, di certo il più importante per
ricchezze e autorità tra i nobili boemi, abituò i figli a bere vino, non appena
li seppe svezzati, e volle che venissero dati loro non quelli meridionali o
bavaresi, che sono più leggeri, ma quelli cretesi, triestini e il Traminer. E
all’imperatore Federico che gli chiedeva per quale motivo lo facesse, rispose:
«I miei figli, quando si saranno abituati, una volta che saranno cresciuti e
avranno iniziato ad amare il vino, berranno sicuri quanto vorranno, e non ne
saranno sopraffatti». «Tu sai – disse Federico – che anche Mitridate fu solito
fare lo stesso. Ma se mai avrò un figlio, lo odierò se non odierà il vino».
[5] Del resto, se il cibo dei re è la gloria, come dice
Alfonso, non è permesso essere privati di quella gloria, prima di averla
conseguita. Le terre d’Italia sono pacificate, e la guerra, se vi è un qualche
timore che scoppi, la rivolgerà contro i Turchi, e a quelli si mostrerà
temibile.
Sul cap. 42
[1] Viriato non a torto fu chiamato il Romolo degli
Spagnoli, Alfonso il Giulio Cesare di quello stesso popolo: se restituisse la
pace alla Toscana, lo chiameremmo senz’altro l’Augusto degli Italici.
Sul cap. 43
[1] Non c’è da meravigliarsi se il re, dopo aver letto
Curzio Rufo, sì sentì alleviato dalla penosa malattia. Mentre leggeva le imprese
di Alessandro da lui raccontate, comprese di essere un ben più grande dominatore
del mondo, egli che non cedeva all’ira e al vino, mentre Alessandro se ne lasciò
vincere.
Sul cap. 44
[1] Al re sembrò indegno che Vitruvio, che insegna in che
modo si possa stare coperti, fosse rimasto scoperto. Ma non conviene che i
Senesi, che gli mostrarono i nemici in maniera scoperta, siano lasciati scoperti
dal re.
Sul cap. 45
[1] Abbiamo sentito spesso Federico dire che avrebbe
preferito esser colto dalla febbre, piuttosto che danzare. Ma i Francesi, per
danzare più facilmente, escogitarono l’impiego di vesti che – turpe a dirsi e
vedersi – non coprono neppure le natiche. La Spagna segue le frivolezze dei
Francesi. L’Italia invece le condanna, le detesta, le rifiuta. Cosa c’è di più
turpe di un uomo vestito in modo tale che, quasi nudo, abbia anche le pudende
scoperte?
Sul cap. 46
[1] Dicono che Dante, condotto agli spettacoli, si fosse
seduto presso un libraio, la cui bottega affacciava sulla piazza, e, trovato un
libro che gli interessava moltissimo, lo lesse con tanta avidità e attenzione,
che, tornato a casa, giurò di non aver visto né sentito nulla delle cose che
erano state dette o fatte in piazza. [2] Riguardo alla
mosca, dato che vi è stato fatto cenno, è il caso di ricordare l’esempio di un
principe francese, di cui vogliamo tacere il nome per decenza: era stato
preparato per lui e per gli uomini della sua corte un banchetto nel giardino,
nel pieno dell’estate, sotto un olmo ombroso, e sciami di mosche, che volavano
lì attorno, si precipitavano su cibi e vino. [3] I
convitati, ai quali la sozzura di quegli animali provocava nausea, non appena
una mosca cadeva in una coppa, gettavano il vino e l’animale, mentre il principe
non sopportava di vedere quello scempio e si indignava in silenzio per lo spreco
del vino. Ma non osò lamentarsi apertamente dinanzi ai grandi nobili che erano
presenti, ma quelli che aveva timore a rimproverare in maniera esplicita a
parole, li smosse col suo esempio. [4] Al fanciullo, che
davanti a lui scacciava le mosche e gli faceva vento con un ventaglio, ordinò di
smettere per un po’. Nel frattempo anche nel suo bicchiere cadde una mosca
piuttosto grande. Allora il principe, con volto allegro, afferrò con due dita
l’ala destra dell’insetto, e dopo averla scossa per qualche momento sul
bicchiere affinché non portasse giù con sé qualche goccia di vino, la gettò a
terra. Tutti i convitati seguirono il suo esempio. [5] Non
c’è da meravigliarsi se l’imperatore Domiziano si metteva a cacciare tanto
spesso quell’animale dannoso e molesto agli dei e agli uomini.
Sul cap. 47
[1] Non fu conveniente che né la tomba di Cicerone né
quella di Vitruvio fossero disonorate, poiché, l’uno, parlando, difese gli
uomini dalla morte, l’altro, scrivendo, lo difese dalla pioggia. Se solo fosse
stato sepolto a Formia quel Vitruvio che ci ha lasciato il libro
sull’Architettura!
Sul cap. 48
[1] Tu ricordi il re pio, che risparmiò persino le pietre
di Cicerone con la stessa riverenza che riservò alle ossa di quell’uomo tanto
grande. Volesse Iddio che quei marmi con cui è costruito l’arco trionfale
trovassero simile venerazione nei posteri! [2] Ma temo che,
una volta collocate all’ingresso del castello, quel luogo verrà un giorno
attaccato, e non saranno risparmiate né per il ricordo del grande re, né per la
sua nobile conoscenza. [3] Siccome il desiderio di
comandare esclude ogni altro sentimento, avrei preferito che la sapienza del re
consacrasse la sua memoria lì, dove si insinua il timore della sola antichità o
della malevolenza.
Sul cap. 49
[1] Il precetto di Ecatone, che Seneca loda molto, «se vuoi
essere amato, ama», giustamente, secondo l’affermazione di Alfonso, non può
essere riferito a Dio, che non amano tutti coloro che Egli ama. [2] Volesse il cielo che i Senesi, i quali molto amano e rispettano il
re Alfonso, non siano ingannati da questa sentenza.
Sul cap. 50
[1] I Senesi non sono meno amici del re rispetto a quanto
lo fu il cavaliere Bozzuto: Alfonso preferì salvare la sua casa, piuttosto che
farsi costruire l’arco trionfale. Anteponga quindi la salvezza dei Senesi al
trionfo del Piccinino.
Sul cap. 51
[1] È proprio del sapiente fare piuttosto che parlare. Il
sapiente non parla se non è necessario, e non dice parole vane, ma solo pesate e
misurate. Per lo stolto non c’è un momento che non faccia chiacchiere, e
facilmente butta fuori parole chi le pronuncia senza pensare.
Sul cap. 52
[1] Confido che la vecchia Siena sarà come quella
vecchietta, che la gemma del re curerà, ma che non perderà la gemma, cioè la
gratitudine per il beneficio ricevuto. Infatti, finché le sue mura saranno in
piedi, sarà fedele e ossequiosa al re e a suo figlio, e ai figli dei figli e a
chi nascerà da loro.
Sul cap. 53
[1] Anche quelli nati ed educati in Grecia e in Italia si
comportano da barbari. Infatti, cosa si addice di più a un barbaro che vivere di
rapina e calpestare ogni giustizia e ogni religione, com’è abitudine degli
Italici?
Sul cap. 54
[1] Ennio, se avesse visto la maggior parte dei re del
nostro tempo, credo che non li avrebbe chiamati sovrani ma sovranacci; e anche i
prelati della Chiesa, li avrebbe chiamati prelatacci, loro che non mostrano
nulla – oltre corone e ornamenti – che sia rispondente alla loro dignità.
Sul cap. 55
[1] È dovere del giusto principe non solo non arrecare
ingiuria a nessuno, ma anche proibire – se può – che lo facciano coloro che
senza una giusta causa arrecano danni ai propri sudditi. Infatti, secondo quanto
afferma Cicerone, colui che non si oppone all’offesa – se può farlo – è
colpevole tanto quanto chi offende la patria o i genitori. [2] Per questo motivo, poiché Alfonso ha la possibilità di proibire a
Piccinino di arrecare danno ai Senesi, e di affliggere quel pio popolo con una
guerra empia, se non lo facesse, non senza ragione sembrerebbe aver trascurato
la giustizia e, dunque, epilettico.
Sul cap. 56
[1] Un pittore di Colonia, famoso, ma prodigo, pigro e
amante del vino, diede in pegno a dei mercanti molte immagini di Cristo, e
preferì, in questo modo, perderle piuttosto che venderle. Quando gli venne
chiesto perché piuttosto non le avesse vendute, disse: «Allora volete che io sia
Giudeo e non Cristiano!».
Sul cap. 57
[1] Jean Gerson di Westfalia, che fu protonotaro
dell’imperatore Sigismondo, dopo la morte di Alberto re dei Romani, visitò i
principi elettori a Francoforte, e tentò con ogni mezzo di convincerli a non
votare Federico, spargendo notizie inventate sui suoi molti vizi, e non contento
di queste cose, mentre Federico si stava recando a Roma per prendere le insegne
imperiali, inviò un’epistola piena di cose blasfeme a papa Nicolò V, con la
quale tentò di non far incoronare Federico. [2] Nessuna di
queste cose sfuggì all’imperatore, e benché potesse far catturare e uccidere
l’uomo, gli permise di vivere a Vienna e di avere a disposizione i suoi beni,
che non erano pochi.
Sul cap. 58
[1] Per i re un giuramento non vale più di una semplice
parola: infatti il principe non può essere obbligato nella volontà in nessun
modo. Ma mi vergogno che oggi la fede sia mantenuta più al di là che al di qua
dei monti. [2] Per la maggior parte dei nostri principi
nati in Italia, si può riscontrare che sono a tal punto ciarlieri, per così
dire, che le promesse delle prostitute sono più affidabili delle loro.
Sul cap. 59
[1] Quando Alessandro, dei duchi di Masovia, che era un
eccelso bevitore, morì a Vienna, e nella cattedrale di Santo Stefano si
celebrava il trigesimo, cui sovrintendevano i canonici alla presenza di molti
nobili, un sacerdote entrò assetato nella cantina della prepositura, e affermò
di averlo visto camminare in mezzo alle botti e, ritornato in chiesa, poiché
trovò i concelebranti che ancora pregavano, disse: «Perché fate queste esequie
ad Alessandro? Egli sta lieto e beve nel suo tempio, e voi qui siete arsi dalla
sete».
Sul cap. 60
[1] Consta che moltissimi si siano pentiti di aver ottenuto
un regno, ma nessuno si è mai pentito di aver appreso le lettere. La conoscenza,
infatti, è simile alla sapienza, che ogni anima brama e non è mai gravosa. [2] Gli affanni di dover reggere un regno hanno oppresso
molti uomini, sebbene la follia dei Bolognesi, che tiene in scarso conto tutti i
regni, desideri regnare un solo giorno con pericolo mortale.
Sul cap. 61
[1] Questo tributo non può essere imposto presso i Boemi,
dove i lupanari e tutti i peccati pubblici sono vietati dalla legge degli
Hussiti. I nostri tollerano mali minori, per evitare tutti quelli maggiori. [2] Ma bene fu fatto coi Napoletani, ai quali la giustizia
divina ha dato questo re, sotto la cui guida si arricchiscono e si innalzano. Se
vorranno essere riconoscenti, renderanno memoria eterna ad Alfonso, che ha
portato qui le ricchezze di tutti i suoi regni.
notes alpha
notes int