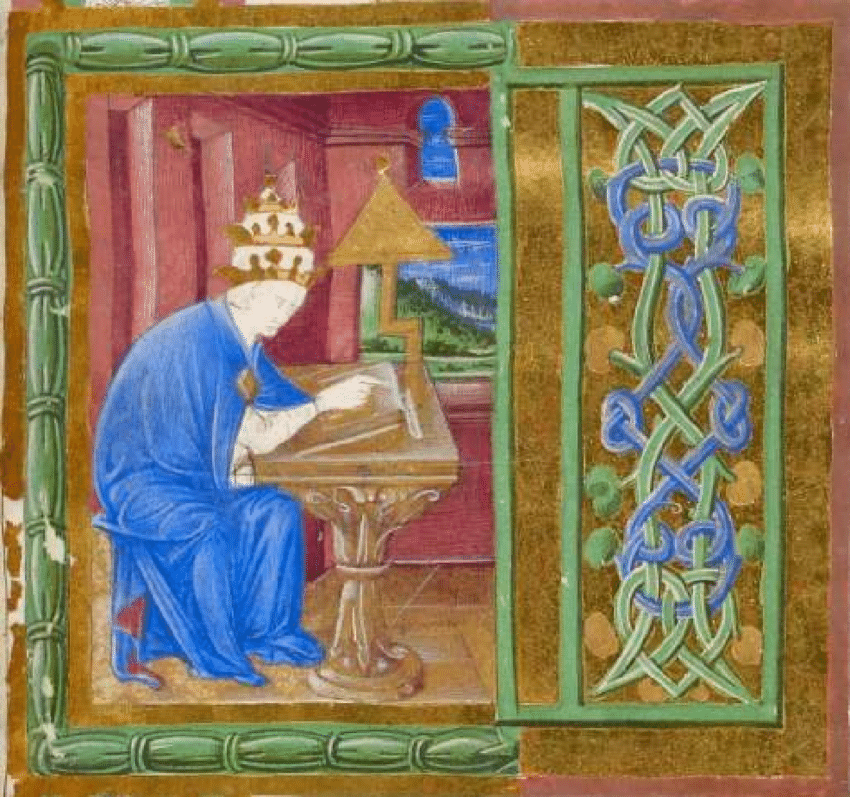
Commento di Enea Silvio Piccolomini agli Alfonsi regis dicta aut facta memoratu digna di Antonio Panormita
date
1456-04-22
title
Enea Silvio vescovo di Siena - Traduzione del Commentario - Libro III
teibody
Sul Proemio
[1] Joan de Hijar nega che Alfonso sia filosofo, perché è
re. Io, proprio per questo, invece, affermo che è filosofo, perché guida un
regno. [2] Infatti, a mio parere, bisogna considerare
filosofi non coloro che dicono cosa fare, ma coloro che fanno ciò che si dice,
coloro che, pur potendo peccare, non peccano, e, così come dici di Alfonso,
impongono un freno alla loro licenza in ogni cosa: la stessa necessità genera
astinenza nella vita privata.
Sul cap. 1
[1] A Giuliano Cesarini, cardinale di Sant’Angelo, che
partecipò al concilio di Basilea, mentre leggeva i libri degli antichi, Oddone
de Varis disse: «Perché ti nascondi tra i morti? Vieni tra noi, che siamo
vivi!». Ed egli rispose: «Essi, piuttosto, vivono per fama. Tu, invece, non sei
vivo né di nome, né di fatto, ma trascorri la vita come le bestie».
Sul cap. 2
[1] Quando l’imperatore Federico chiamò i senatori alla
corte, disse: «Magari i miei consiglieri potessero lasciare due cose nell’atrio
del palazzo! In questo modo, anche loro potrebbero dare buoni consigli e sarebbe
facile per me giudicare tra i consigli». Quando gli fu chiesto quali fossero
queste cose, rispose: «Simulazione e dissimulazione».
Sul cap. 3
[1] Poiché l’imperatore Sigismondo disse a un soldato
veterano che gli chiedeva di mantenere le promesse: «Ma la tua richiesta è stata
eccessiva», il soldato rispose: «Conservando l’onestà, avresti potuto rifiutare
quando feci la richiesta, ma ora non puoi più rifiutare ciò che hai promesso
senza vergogna». Allora Sigismondo disse: «Se devo scegliere una delle due cose,
sopporterò più facilmente di perdere la mia reputazione che i miei beni».
Sul cap. 4
[1] Ladislao il Postumo, re d’Ungheria e di Boemia, sebbene
ancora bambino, quando fu a Roma disse di non sembrargli che vi fossero uomini
che ignorassero le lettere.
Sul cap. 5
[1] Siccome a Barbara, che fu moglie dell’imperatore
Sigismondo, e che gli sopravvisse come vedova dopo la sua morte, qualcuno disse
di imitare l’esempio della tortora, che mantiene in perpetuo la castità dopo la
morte del suo compagno: «Se mi chiedi – disse – di imitare gli uccelli, che non
hanno ragione, perché non suggerisci piuttosto le colombe e i passeri?».
Sul cap. 6
[1] Tornato a casa dalla corte imperiale, dove aveva
trascorso molto tempo, Gregorio di Amburgo, che era il più grande esperto di
diritto e di eloquenza tra tutti i Tedeschi, incontrò un amico non lontano da
Norimberga, che gli disse che sua moglie stava bene: «Se mia moglie è viva –
disse Gregorio – io sono morto».
Sul cap. 7
[1] Ottacaro re di Boemia, quando gli vennero riferiti
sinistri pettegolezzi sulla castità della moglie, disse: «È legge della natura,
questa: chi fa le corna, non deve rifiutarsi di portarle».
Sul cap. 8
[1] Giovanni di Váradi, vescovo e cancelliere del regno
d’Ungheria, secondo a nessuno tra i cittadini del regno per eleganza di modi e
conoscenza delle lettere, quando vide che le prefetture delle città e delle
province erano affidate a uomini nuovi e sconosciuti, disse: «Fra un anno
vedremo se la scelta del re è stata buona. Se mi avesse dato fiducia, avrei
selezionato quelli già esperti di questi incarichi, non quelli vanno ancora
sperimentati».
Sul cap. 9
[1] A Ulrico de Rosis, potente per ricchezza e autorità tra
i nobili boemi, quando gli riferì che, in sua assenza, era morto il fratello e
Praga gli si era ribellata, rispose che il fratello aveva pagato il suo tributo
alla natura, mentre Praga, quanto più orgogliosamente intendeva liberarsi, tanto
più duramente sarebbe stata sconfitta.
Sul cap. 10
[1] Chiliano, parassita del margravio Alberto, quando
qualcuno gli disse: «Perché ti fai passare per stupido quando sei
intelligente?», rispose: «Oh, come la fortuna mi tratta ingiustamente! Più cerco
di mostrarmi sciocco, più mi considerano prudente. Al contrario, mio figlio, che
cerca di sembrare saggio, è giudicato il più stupido di tutti».
Sul cap. 11
[1] Credo che, quando inviò le sue Satire ad Alfonso, Filelfo avesse letto quanto gli antichi scrivono di
Teodosio II, che a Oppiano, il poeta che scriveva della natura dei pesci, donò
una moneta d’oro per ogni verso: perciò i suoi carmi sono chiamati aurei.
Sul cap. 12
[1] Mentre l’imperatore Federico tornava in Austria
dall’Italia, venne a sapere che gli Austriaci avevano preso le armi e che, dopo
aver accolto alcuni soldati boemi, avevano intenzione di assediare Neustadt; per
questo motivo, tutti, compresi gli amici, suggerivano a Federico di non passare
per le montagne della Stiria, poiché non avrebbe avuto possibilità di fuggire,
una volta arrivato in Austria. [2] A ciò Federico rispose:
«Non mi sembra probabile che gli Austriaci cadano in tale perfidia da attaccare
il loro signore con l’esercito. E non sono di quelli che preferiscono fuggire,
invece di essere catturato o ucciso. Cosa vogliono? Che noi, contro la nostra
volontà, rinunciassimo alla tutela di Ladislao, ancora tenero fanciullo,
riconducendolo alla condizione di ostaggio, da cui l’abbiamo liberato? Se
continuano a chiedere ciò, butterò in mezzo ad Austriaci, Boemi e Ungheresi quel
pomo che, secondo il racconto, si contesero le tre dee Giunone, Venere e
Minerva».
Sul cap. 13
[1] Riguardo a Pippo Spano Fiorentino, della famiglia degli
Scolari, che, avendo combattuto con fedeltà e successo in molte guerre,
dall’imperatore Sigismondo era stato innalzato tanto tra gli Ungheresi, che
tutti lo consideravano il secondo capo del suo regno, e molti persino il primo,
si racconta che Sigismondo avesse detto: «Se Pippo volesse, messomi in mano lo
scettro, mi vedrebbe uscire dai confini del regno da solo e nudo».
Sul cap. 14
[1] Mentre l’imperatore Federico andava a Roma, seppe dai
comandanti, che aveva a Mautern, che Ulrico Eitzinger, il maggiore tra i nobili
dell’Austria per ricchezze e industria, aveva oltrepassato il Danubio e si
temeva che lì avesse colloqui segreti con i Moravi per organizzare una rivolta
in assenza del principe, e quindi, tornando, mettesse in catene Ulrico; [2] in risposta, l’imperatore disse loro che è pericoloso
mettere in prigione un uomo così illustre e potente, se non si ha il coraggio di
punire il colpevole o di liberare l’innocente; pertanto, non credeva che Ulrico,
poiché era il suo consigliere, fosse immemore del giuramento a lui prestato
prima che fosse dimostrato.
Sul cap. 15
[1] Quando Federico imperatore educava Ladislao, re
d’Ungheria e di Boemia, non mancavano persone malvagie che suggerivano di
uccidere il ragazzo, la cui vita avrebbe causato grandi molestie all’imperatore,
mentre la morte gli avrebbe procurato regni e grandi ricchezze. [2] Rispondendo, Federico disse: «Quindi volete che io sia un re
ricco, piuttosto che giusto e pio. Ma io preferisco un buon nome a tutte le
ricchezze».
Sul cap. 16
[1] Lo spagnolo Giovanni, cardinale di Sant’Angelo, quando
si recò in Austria come legato apostolico e venne a sapere delle entrate e delle
spese dell’imperatore Federico, osservò: «Si diceva – affermò – che Federico
fosse troppo parsimonioso. Ma, a mio giudizio, è molto generoso, poiché adegua
le spese alle sue possibilità». D’altronde, Sigismondo e Alberto, che regnarono
prima di lui su regni ricchissimi come Boemia e Ungheria, furono principi quasi
prodighi, la cui generosità oscura quella di Federico.
Sul cap. 17
[1] Quando l’imperatore Sigismondo dichiarò di odiare gli
adulatori come una peste, Brunorio di Verona rispose: «Anzi, non c’è categoria
di persone che ami di più. Altrimenti, quale potere avrebbero presso di te
Mathko Bonus, Lorenzo Palatino, Ursacius Michael, Kaspar Schlick, se non
avessero guadagnato il tuo favore adulandoti?», Sigismondo replicò: «Hai
ragione, Brunorio. È una verità di natura: più si dice di evitare gli adulatori,
più vi si rimane attaccati. E nemmeno tu saresti rimasto con me tanto a lungo,
se non avessi imparato a blandire il mio carattere».
Sul cap. 18
[1] Un predicatore dell’ordine dei Minori, a Vienna, notò
che l’imperatore Alberto, padre di Ladislao, si era addormentato durante il suo
sermone. Allora, alzando la voce, esclamò: «Chiedo a voi presenti: i principi
possono salvarsi?» E, dopo aver reso la questione incerta e molto difficile,
vedendo il re ormai sveglio e molto attento, concluse: «State tranquilli, state
tranquilli. Se i principi muoiono battezzati o da bambini, la loro salvezza non
è disperata».
Sul cap. 19
[1] La Toscana, oppressa dalle guerre, si dibatte come in
travaglio, e implora dal re la cintura della santa Ferma. Nessun altro potrebbe
concederle la salvezza.
Sul cap. 20
[1] Federico, duca d’Austria e figlio dell’imperatore
Alberto, in procinto di affrontare Ludovico di Baviera, che gli contendeva
l’impero, pur sapendo che i margravi del Brandeburgo si erano alleati col
nemico, versò loro comunque il denaro promesso, preferendo che fossero loro a
essere accusati di aver violato i patti, non lui.
Sul cap. 21
[1] Quando Sigismondo, che spesso è stato menzionato, prese
in moglie Maria, regina d’Ungheria, fu convocato un grande parlamento degli
abitanti del regno a Buda. Durante quel parlamento, la regina denunciò il
tradimento di alcuni tirannelli che avevano cercato di spogliarla del regno. [2] Sigismondo, esaminata e giudicata la questione insieme
ai giudici del regno, fece decapitare trentadue di quei ribelli, azione che gli
causò in seguito difficoltà e problemi in gran numero.
Sul cap. 22
[1] Tra Giovanni, padre di Carlo IV, ed Enrico, duca di
Carinzia, si protrasse una lunga e difficile contesa per il regno di Boemia,
durante la quale un tale venne segretamente da Giovanni a offrirgli di
avvelenare il suo nemico dietro compenso. [2] Giovanni
rispose: «Se tu avessi ucciso Enrico senza che io lo sapessi e fossi venuto da
me, avresti avuto una punizione come compenso, per esserti macchiato le mani di
sangue reale. Invece, pretendi che io sia complice di un crimine così
grave».
Sul cap. 23
[1] Žižka, un Boemo nato da umili origini, dotato di grande
forza fisica e spirituale ma di animo perverso, guidò gli eretici Hussiti in
molte battaglie contro i fedeli che ancora resistevano. Aveva perso un occhio
durante l’infanzia e l’altro durante l’assedio di un castello. Nonostante fosse
cieco, non rinunciò al comando, e grandi eserciti lo seguirono, infliggendo
gravi sconfitte non solo ai Boemi ma anche ai Tedeschi. [2]
Sul letto di morte, alla domanda su cosa fare del suo corpo, rispose:
«Scuoiatemi. Lasciate la carcassa alle bestie e fate con la mia pelle un tamburo
da usare in battaglia: come i nemici mi hanno temuto, allo stesso modo non ne
sopporteranno il suono».
Sul cap. 24
[1] Astorgio di Faenza insegna quanto poco affidamento si
possa fare tanto su Piccinino quanto sugli altri comandanti di eserciti che
l’Italia alleva.
Sul cap. 25
[1] Sebbene io ascolti volentieri tutto ciò che racconti
riguardo ad azioni o parole di Alfonso, nessuna accolgo con più piacere nel mio
animo quanto quella risposta, quasi divina, data a Lluís Despuig, che un re
concede la pace, non la vende. Anche noi siamo venuti qui per chiedere la pace,
non per comprarla.
Sul cap. 26
[1] Alfonso deve molto a Filippo, ma di più a Cristo. Per
Filippo decise di intraprendere una guerra contro i Veneziani. Perché allora non
prende le armi per Cristo contro i Turchi? I Turchi sono più pericolosi dei
Veneziani, e Cristo è molto più grande di Maometto.
Sul cap. 27
[1] Al senese Mariano Sozino, esperto nell’uno e nell’altro
diritto, fu chiesto un giorno perché si dedicasse meno del solito agli studi
letterari. Egli rispose: «Ho preso moglie». [2] Interrogato
di nuovo sul motivo per cui Socrate, dopo essersi sposato, non aveva trascurato
gli studi filosofici, disse: «Santippe era bisbetica e, a quanto credo, di
aspetto poco gradevole, mentre mia moglie è virtuosa e non priva di
bellezza».
Sul cap. 28
[1] Il senese Memmo Agazzari, che fu vescovo di Grosseto,
prima di ricevere quell’incarico si imbatté in Pietro di Montalcino, un
astronomo di buona fama, che, afflitto dalla podagra, lo trattenne a lungo
raccontandogli una cosa dopo l’altra. Quando Memmo vide passare un conoscente,
disse: «Ascolta tu questo podagroso, perché le mie orecchie ormai si sono
intorpidite a forza di sentirlo».
Sul cap. 29
[1] Durante l’assedio di Praga, i capi della città, che
odiavano Sigismondo, istigavano abilmente il popolo a lanciare contro di lui
insulti osceni e provocatori. Speravano, infatti che, così facendo,
l’imperatore, irritato, avrebbe minacciato torture o punizioni esemplari, e i
cittadini, terrorizzati, avrebbero affrontato con più costanza le fatiche
dell’assedio. Ma l’imperatore, comprendendo l’intento, fece proclamare da un
banditore l’impunità per tutti gli insulti ricevuti.
Sul cap. 30
[1] Si presentò all’imperatore Rodolfo una persona che
prometteva di uccidere Ottocaro, re di Boemia, durante una battuta di caccia, a
condizione che gli fosse garantita una ricompensa. [2]
Rodolfo rispose: «Sebbene Ottocaro sia nostro nemico e lo odiamo, questo non ci
porterà mai a superare i limiti della giustizia e della moderazione».
Sul cap. 31
[1] «Tra i filosofi – disse Ugo Senese – trovo molte
eresie, che si potrebbero facilmente cancellare se ci si mettesse d’accordo sul
significato effettivo delle parole».
Sul cap. 32
[1] Alberto, duca d’Austria, prima di assumere il titolo di
imperatore romano, scatenò una feroce persecuzione contro gli Ebrei, ordinando
che tutti quelli sotto la sua giurisdizione fossero uccisi se non si fossero
convertiti alla fede in Cristo e nell’unico vero Dio. [2]
Molti, spaventati, accettarono il battesimo. Tra loro vi era uno che Federico,
prima di diventare imperatore, accolse nella sua dimora e amò come un fratello,
poiché erano coetanei. [3] Questi, anni dopo, mosso dal
pentimento, dichiarò di voler tornare alla fede ebraica. Federico tentò di
dissuaderlo dal lasciare la via della vita, ma le sue parole non ebbero effetto.
Chiamò allora i teologi della scuola di Vienna perché istruissero il giovane,
aggiungendo preghiere, lacrime, promesse e minacce. Tuttavia, quando si rese
conto che i suoi sforzi erano vani, sacrificò con riluttanza l’affetto fraterno
a un sentimento di pietà religiosa. Con grande dolore consegnò il giovane al
tribunale. [4] Condotto al supplizio, quello, senza essere
legato – così come aveva richiesto – si lanciò intrepido tra le fiamme,
intonando un canto ebraico, e cantando, morì sul rogo.
Sul cap. 33
[1] Il boemo Žižka, ordinò che non gli fosse portata
nessuna preda dai luoghi conquistati, eccetto che tele di ragno: così infatti
chiamava i prosciutti e le carni salate appese ai soffitti delle case
rustiche.
Sul cap. 34
[1] San Bernardino da Siena affermò che il prestito a
interesse poteva essere praticato senza peccato: «Qualora il denaro venga dato a
chi non sia in grado di restituire nemmeno il capitale».
Sul cap. 35
[1] Nel quarantaseiesimo anno precedente, tra l’ordine di
Santa Maria dei Teutonici e il re di Polonia Ladislao nacque una disputa sui
confini del regno, ed entrambe le parti radunarono grandi eserciti. Tuttavia, i
Prussiani, esultanti sia per il numero dei loro soldati sia per la ferocia del
loro animo, inviarono tramite un araldo due spade al re, perché ne scegliesse
una per combattere. [2] Egli, mentre offriva sacrifici al
suo Dio con il fratello Vitoldo, udendo il messaggero, disse: «Non rifiuto
l’insegna della battaglia». Consacrando la spada scelta, la cinse e, avendo dato
ordine di combattere, mandò avanti i Lituani, venuti in suo soccorso. Dopo il
loro massacro, i Prussiani furono anch’essi abbattuti dai Polacchi sopraggiunti.
[3] Alla fine della giornata la vittoria fu del re;
quattrocento cavalieri dell’Ordine, compreso il Gran Maestro, perirono, e molti
soldati furono uccisi, mentre i sopravvissuti furono catturati. Tutta la
Prussia, tranne la città di Marienburg, passò ai Polacchi.
Sul cap. 36
[1] Quando il Palatino Lorenzo d’Ungheria criticò l’agire
dell’imperatore Sigismondo perché concedeva la vita e i beni ai nemici sconfitti
e addirittura li accoglieva come amici, Sigismondo rispose: «A te sembra utile
uccidere il nemico, poiché un morto non suscita guerre. Ma io uccido il nemico
risparmiandolo e ne faccio un amico alzandolo in piedi».
Sul cap. 37
[1] Durante la lunga guerra contro i Boemi, che il duca
Alberto d’Austria condusse prima di diventare imperatore, gli fu chiesto chi
intendesse porre al comando delle truppe. Rispose: «Se cercate un altro
comandante dell’esercito, mi chiamate invano duca, che significa
condottiero».
Sul cap. 38
[1] Luigi duca di Baviera, imprigionato da Enrico, principe
della stessa famiglia, non si alzò mai in piedi né annuì con il capo quando
quello lo visitava, né acconsentì a nulla di ciò che gli veniva chiesto o
proposto. Mantenne, da prigioniero, lo stesso volto e la stessa austerità di
comportamento che aveva quando era libero.
Sul cap. 39
[1] I nobili ungheresi, congiurando contro Sigismondo,
irruppero armati nella reggia per catturarlo o ucciderlo, qualora non
riuscissero a prenderlo vivo. [2] Egli, riconosciutoli, si
fece avanti con un pugnale in mano e disse: «Chi di voi oserà alzare la mano
contro di me? Che cosa ho fatto per essere ucciso, io vostro re? Si faccia
avanti chi ha coraggio e si misuri con me da solo». Colpiti dalla sua voce e
audacia, i congiurati si ritirarono, ciascuno temendo per sé.
Sul cap. 40
[1] Nella guerra che sei anni fa Alberto, margravio di
Brandeburgo, combatté con grande accanimento contro i Norimberghesi, Gravenburg
fu da lui assediata con grande forza. Questa cittadina si trova in una valle, a
ventiquattro miglia da Norimberga, ed è protetta da mura e fossati, con
cinquecento soldati a presidio oltre agli abitanti. [2]
L’assedio fu avviato in quattro punti diversi. Alberto scelse per sé la parte
della città dove le mura erano più alte e il fossato più profondo. Durante
l’assalto, quando la città fu conquistata, egli stesso fu il secondo a salire
sulle mura e il primo a entrare in città. [3] Circondato
dagli abitanti, resistette combattendo a lungo, nonostante molti si scagliassero
contro di lui, finché altri soldati, superate le loro sezioni di mura, non
accorsero in suo aiuto. La città fu catturata e saccheggiata, ma non fu inflitta
alcuna violenza alle donne, poiché tra i Tedeschi tale comportamento è
considerato un crimine imperdonabile.
Sul cap. 41
[1] Iodoco, margravio di Moravia, visitò suo zio Venceslao,
re di Boemia e dei Romani. Quest’ultimo lo convocò nella parte più interna della
sua dimora e gli disse: «Sebbene sappia bene che non compete alla mia dignità,
dal momento che gli elettori dell’impero mi hanno destituito dalla guida dei
Romani, mi conforta sapere che quest’onore non è uscito dalla nostra famiglia.
Accetto di buon grado che tu sia stato scelto come mio successore». [2] Iodoco, spaventato da tali parole, si inginocchiò
davanti al re e affermò di non essere responsabile, poiché era del tutto ignaro
di quelle cose. Venceslao lo rassicurò: «Non temere, nipote. Non abdico con
riluttanza, né, se volessi mantenere il potere, oserei violare i legami di
sangue. Abbi fiducia e accetta il regno che ti è stato affidato; usa come
desideri gli uomini, le armi e le risorse del mio regno». Dopo averlo confortato
e caricato di doni, lo congedò. Tuttavia, Iodoco sopravvisse solo sei mesi,
lasciando il posto a Roberto di Baviera sul trono imperiale.
Sul cap. 42
[1] Quando la Chiesa cattolica fu divisa – poiché tre
contendenti si disputavano il papato romano: Pietro di Luna, Baldassarre Cossa e
Angelo Corario – l’imperatore Sigismondo organizzò un concilio generale a
Costanza degli Svevi, come la chiamiamo noi. Viaggiò instancabilmente in Italia,
Francia e Spagna per portare tutte le nazioni al consenso su un unico papa. Con
la rinuncia di uno di loro, la pace fu restituita alla Chiesa. [2] Fu eletto papa Martino V, uomo prudente e amante della pace. Dei
tre contendenti, due furono dichiarati scismatici dal sacro sinodo, mentre il
terzo rinunciò spontaneamente al pontificato.
Sul cap. 43
[1] Per salvare la vita di un singolo soldato, Alfonso si
gettò in un fiume impetuoso, rischiando la propria vita per evitarne la perdita.
Perché dunque non dovrebbe prendersi cura del popolo senese e difendere la
libertà e le fortune di una città tanto amica?
Sul cap. 44
[1] Sigismondo, catturato dagli Ungheresi, fu affidato a
due giovani di cognome Garai, il cui padre era stato condannato a morte per suo
volere, affinché lo custodissero in attesa di una decisione comune dei
cospiratori. Quando cercò invano di persuaderli a liberarlo, convocò la loro
madre vedova e le disse: «So, donna, quanto sia stata dolorosa per te la morte
di tuo marito e quanto tu mi sia ostile come responsabile di tale evento.
Tuttavia, giuro sugli dèi che acconsentii con riluttanza alla fine di un uomo
così eminente. Fu la regina ad accusarlo, e i nobili del regno pronunciarono la
sentenza di morte. [2] Io, ignaro delle vostre fazioni, ero
appena salito al trono. Quello che i regnanti decisero, mi sembrò necessario
eseguire. Anche ammettendo che abbia ordinato consapevolmente la morte di tuo
marito, non permettere che per questo tu ti opponga a me con l’ira dei tuoi
figli o di altri. Quale vantaggio avreste? Se mi uccideste, i miei fratelli e
amici vendicherebbero il mio sangue e l’Ungheria non rimarrebbe senza re. I re
temono gli esempi: nessuno che abbia versato sangue reale è gradito presso di
loro. [3] Tuttavia, se mi libererai, sposerò una delle
figlie di Ermanno, conte di Celje, tuo parente, e con il loro sostegno
riconquisterò il trono. Tratterò i tuoi figli con grande affetto e farò in modo
che tutta la tua discendenza tragga beneficio da questa decisione». [4] Convinta, la donna liberò il re. Sigismondo sposò
Barbara di Celje e, dopo aver sconfitto i ribelli, recuperò il trono, mantenendo
la promessa ed elevando i giovani Garai al di sopra di tutti i nobili. Tra i
loro discendenti vi fu Ladislao Ban, eminente per potere e autorità tra i nobili
d’Ungheria.
Sul cap. 45
[1] L’Austria è una nobile provincia, ricca per la terra e
gli uomini, formata dal distacco di due regioni. Infatti, la parte che va dal
fiume Leita fino al fiume Enns apparteneva al territorio pannone, mentre quella
dall’Enns all’Inn al Norico. L’Inn, grande fiume che sgorga dalle Alpi d’Italia,
si unisce al Danubio presso la città di Passavia. Il Leita, piccolo fiume che
discende dai monti della Stiria, sfocia nel Danubio tra le città di Vienna e
Presburgo. [2] A nord di questa provincia confinano i Boemi
e i Moravi, a sud ci sono i monti della Stiria, a est gli Ungari e a ovest i
Bavari. Il Danubio, per tutta la sua lunghezza, l’attraversa nel mezzo. [3] In origine, fu governata da margravi, poi da duchi. La
stirpe ducale si estinse in una donna, che fu sposata da Ottocaro, re di Boemia,
più desideroso del regno che del matrimonio stesso, al punto che, mentre lei era
ancora in vita, prese in moglie un’altra donna proveniente dalla Polonia. [4] Tuttavia, quando Rodolfo imperatore dei Romani
rivendicò l’Austria – essendo venuti meno gli eredi maschi della stirpe dei
duchi – come devoluta all’impero, e non potendo arginare in altro modo il re di
Boemia, che aveva infranto ogni accordo, decise infine di risolvere la disputa
con le armi. [5] La battaglia fu combattuta oltre il
Danubio: Ottocaro era sostenuto da Boemi, Misnensi, Polacchi e Ungari; Rodolfo
condusse l’impresa con Svevi, Franconi, Austriaci e Stiriensi uniti in alleanza.
Le forze avversarie superavano di gran lunga le sue per numero, ma i soldati di
Rodolfo prevalsero per valore. In quella battaglia furono compiute grandi
stragi, e Ottocaro fu ucciso. Rodolfo ordinò che fosse sepolto con onore. [6] In seguito concesse il ducato d’Austria a suo figlio
Alberto, il maggiore, da cui ebbero origine coloro che oggi possiedono
l’Austria: Federico, Ladislao, Alberto, Sigismondo. [7] In
quello scontro, poiché l’esercito soffriva la sete, si narra che un contadino,
che stava portando da bere ai mietitori, avesse recato un’anfora colma di sidro
e l’avesse offerta all’imperatore. Ma lui, vedendola, disse: «Restituite il
recipiente al suo padrone: io avevo sete per l’esercito, non per me stesso».
Sul cap. 46
[1] Alberto, margravio di Brandeburgo, teneva prigioniero
Ludovico il Vecchio, duca di Baviera, e gli chiese non poche cose. Poiché lui
rifiutava, minacciava di consegnarlo nelle mani di un principe duro e a lui
ostilissimo. [2] Allora Ludovico disse: «Ciò che avresti
potuto ottenere da me in libertà, puoi ottenerlo anche ora che sono prigioniero.
Se pretendi qualcosa in più, sappi che il mio corpo è in tuo potere, ma il mio
spirito non ti sarà mai soggetto».
Sui capp. 47-48
[1] Trovandomi a Calais, in territorio dei Morini, da cui
si dice vi sia la via più breve per l’isola d’Inghilterra, seppi, per voce di
Niccolò Albergati, cardinale di Santa Croce, uomo santissimo, che Filippo duca
di Borgogna, prima schierato con gli Inglesi, aveva fatto atto di sottomissione
al re di Francia. [2] Quando lo venne a sapere il
governatore del luogo, ordinò subito che io, segretario di quel cardinale, fossi
trattenuto: tale circostanza mi avrebbe arrecato gravi danni, se il cardinale di
Winchester, che mi conosceva, non avesse subito ordinato il mio rilascio.
Sul cap. 49
[1] Federico il Vecchio, duca d’Austria, zio
dell’imperatore Federico, spesso, mutati gli abiti, si aggirava da solo fra i
contadini, e, arando e svolgendo vari lavori dei campi dietro compenso,
conversava con loro di sé stesso e dei suoi cortigiani. [2]
Interrogato sul motivo di tale comportamento, rispose: «Non potrei in alcun
altro modo sentire la verità su di me».
Sul cap. 50
[1] Tra le imprese del re, questa è la più grande e
illustre, e Dio non abbandona mai chi confida in Lui. [2]
Enrico, re d’Inghilterra, padre dell’attuale sovrano, una volta accerchiato
dall’esercito del re di Francia, offrì di rinunciare a tutti i territori
conquistati in Francia, purché gli fosse permesso di allontanarsi indenne con i
suoi uomini. [3] Poiché i Francesi non accettarono, quella
notte, convocati tutti i comandanti, disse: «Compagni, non possiamo né fuggire
né ottenere pace dai nemici, nemmeno offrendoci di rinunciare al regno di
Francia. Solo le armi ci possono proteggere. Non c’è motivo di temere un
esercito numeroso: un Dio giusto aiuterà una causa giusta. Andate, confessatevi
l’un l’altro i vostri peccati e, per ricordare il sacramento dell’eucarestia del
Salvatore, porgetevi l’un l’altro un po’ di terra. Domani il Signore ci libererà
dalle mani dei nemici». [4] Così, sciolta l’assemblea,
diede ordine ai soldati di riposare dopo aver fatto ciò che egli aveva
comandato. Il giorno seguente, allo spuntar della luce, iniziò la battaglia.
Incredibile a dirsi: ottomila dei suoi misero in fuga sessantamila nemici; ne fu
uccisa una grande moltitudine, la quasi totalità della nobiltà francese fu
catturata e soltanto in pochi si salvarono con la fuga. Proprio quel giorno
fiaccò in modo decisivo la potenza dei Francesi.
Sul cap. 51
[1] Si racconta che, mentre si trovava in Toscana, Ferrante
osservasse con scrupolo i comandi paterni, guadagnandosi l’ammirazione dei suoi
alleati in modo straordinario. Perfino i nemici, sebbene lo temessero, non
potevano fare a meno di amarlo. Ma quale cambiamento è quello che è nella mano
dell’Altissimo! I Veneziani, che egli definiva carissimi e amici, non furono più
benvoluti, mentre i Fiorentini, contro i quali era stato inviato l’esercito,
furono accolti in amicizia. [2] Ricordo qui le parole che
Girolamo scrive a Rufino: «L’amicizia che può finire non è mai stata vera».
Girolamo si ingannò nel pensare che Rufino gli sarebbe rimasto sempre fedele;
non c’è da stupirsi se anche l’opinione di Alfonso fu smentita dai fatti.
Sul cap. 52
[1] Cicerone dice che tutta la filosofia non è altro che
una sorta di preparazione alla morte, e non sbaglia in questa sapiente
affermazione. Infatti, perché mai impariamo i precetti di una vita retta, se non
per sapere come morire bene? La nostra vita è come una commedia il cui ultimo
atto tratta della morte. [2] Nessun poeta è considerato
bravo se non spiega con saggezza tutti gli atti fino alla fine. Ma Dio ha agito
meglio con noi. Infatti, anche se tutta la nostra vita precedente è stata
misera, basterebbe, per conquistare il cielo e la beatitudine, affrontare la
morte con animo sereno e forte, e riconciliarci con Dio prima dell’ultimo
respiro. [3] Non ci contraddice sant’Agostino quando
afferma che è impossibile vivere male e morire bene, o che muore male chi ha
vissuto bene: egli distingue, infatti, la vita e la morte; ed è vero, perché da
morti non possiamo meritare più nulla. [4] Eppure noi
diciamo che si muore bene quando, proprio al termine della vita, si prova vera
contrizione e pentimento dei peccati, pur sapendo quanto ciò possa talvolta
ingannare. Ciononostante, è risaputo che perfino uomini che hanno vissuto a
lungo in modo santo sono morti disperando, e che altri, sebbene fossero stati
scelleratissimi, morirono in modo lodevole, avendo ottenuto negli ultimi istanti
la misericordia di Dio ottimo e santissimo. [5] Ma – mi
chiedo – quale preparazione alla morte così autentica e così efficace si trova
presso i filosofi, che possa uguagliare il conforto che, secondo quanto
racconti, Alfonso arrecò a Gabriele Sorrentino? Leggiamo in Plutarco, nel De bono mortis, che Socrate disquisiva di filosofia
mentre si apprestava a bere il veleno; ma è nulla in confronto ad Alfonso.
Dunque, nonostante Joan de Hijar lo neghi, Alfonso è filosofo.
notes int
notes alpha