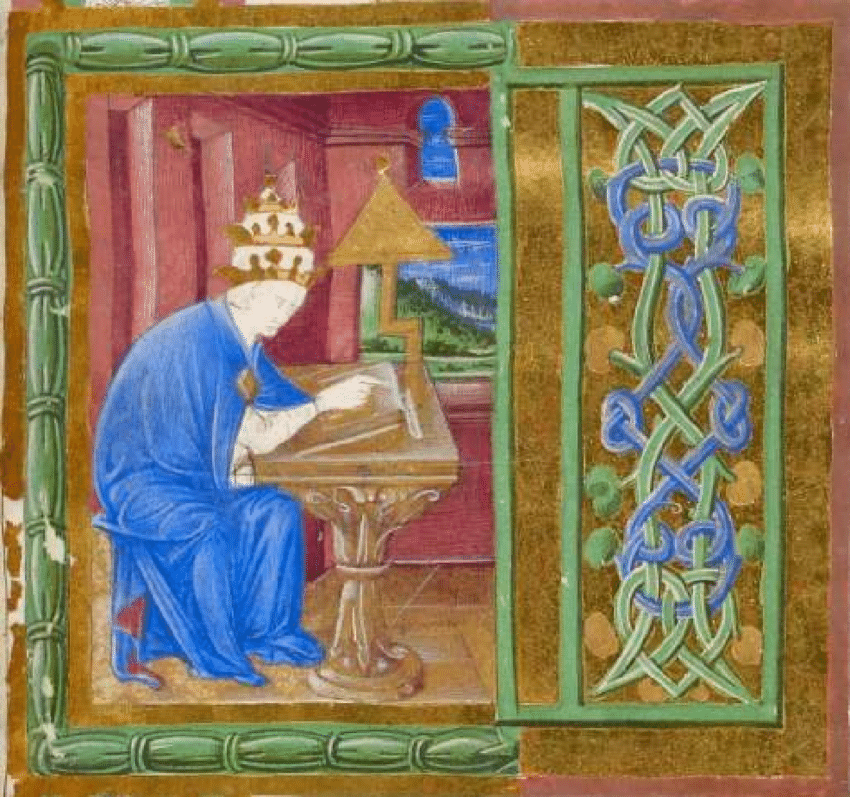
Commento di Enea Silvio Piccolomini agli Alfonsi regis dicta aut facta memoratu digna di Antonio Panormita
date
1456-04-22
title
Enea Silvio vescovo di Siena - Traduzione del Commentario - Libro IV
teibody
Sul proemio
[1] La Spagna, che è da comparare alle terre migliori, non
fu solita dare a Roma e all’Italia solo imperatori e re, ma anche cardinali e
papi dalla vita purissima e dalla dottrina ammirevole. Infatti, la Spagna ci ha
dato papa Damaso, di eccelsa virtù e famosissimo per lo studio di tutte le arti.
[2] Ora dalla stessa provincia abbiamo avuto in sorte
Callisto III, che riteniamo ottimo in virtù del nome. È risaputo che nel sacro
collegio dei cardinali molti sono gli Spagnoli degni di lode: vediamo nel
collegio i cardinali Alfonso di Sant’Eustachio e Giovanni di San Pietro in
vincoli, la cui morigeratezza dei costumi e l’accortezza nel comportamento è
stata tale che hanno portato dalla loro parte tutto il sinodo. Noi stessi
abbiamo servito nella segreteria di Giovanni. [3] Oggi la
Spagna annovera tra i cardinali anche Giovanni di San Sisto, Antonio di Lleida e
un altro Giovanni, di Sant’Angelo, che or ora è andato come legato in Ungheria,
per raccogliere truppe contro il Turco. Il mondo romano è illuminato da quelle
due stelle di sapienza teologica; e il terzo non è inferiore a nessuno nella
scienza del diritto. [4] In verità Alfonso, come dici, non
trae lode dalla Spagna ma egli stesso rende lustro alla Spagna. Sebbene sia
tanto religioso e osservatore del culto divino, come scrivi, non è immemore
della dottrina evangelica e dopo i digiuni, le preghiere e le altre opere di
pietà, cui si dedica costantemente, si dichiara servo inutile. E, infatti, in
questi giorni, essendo venuto da lui il messo apostolico per trattare della pace
della Toscana, tra le varie altre cose sapienti ha detto: «So che, dopo aver
iniziato a regnare, ho elevato molti uomini da umile condizione a grandi
ricchezza e potenza, che poi si sono dimostrati immemori del bene ricevuto. La
cosa non mi meraviglia, dal momento che io stesso sono tormentato dal vizio
dell’ingratitudine. Infatti, chi ha ricevuto da Dio più benefici di me, che,
nato da re, ho ottenuto per diritto ereditario grandissimi regni e ne ho
conquistati altri non minori con le armi? Pochi re mi precedono tra quelli
cristiani. [6] La natura mi ha concesso un ingegno non
ottuso, una memoria non debole, un corpo sano, una vita piuttosto lunga e non
guastata dalle malattie, godo di abbondanti ricchezze, lussi, piaceri; ho avuto
anche una certa formazione letteraria. Ma dov’è la mia gratitudine? Cosa faccio
o ho fatto per aver ottenuto tanti e tanto grandi doni dalla divina clemenza?
Sono certamente consapevole di essere ingrato e perciò di essere degno della
stessa accusa e pena di cui penso che siano degni gli altri che sono stati
ingrati nei miei confronti, tanto più che è più grave ingannare Dio che gli
uomini. [7] Tuttavia, se mi sarà concesso di vivere, ho in
animo di rimediare a ciò che finora ho trascurato in abbondanza. Infatti, ho
deciso di vendicare gli oltraggi che la crudelissima nazione dei Turchi infligge
quotidianamente a Gesù Cristo, il nostro vero e grande Dio, sia in Grecia, sia
in Asia, e ho già preparato navi, uomini e armi a questo scopo. Quindi, non c’è
motivo per cui si possa pensare che voglia turbare in alcun modo la pace della
Toscana che ora si sta negoziando». [8] Queste cose ha
detto il re, che, se manterrà la sua promessa, sarà riconosciuto da tutta Europa
come il salvatore della religione cristiana inviato dalla Spagna.
Sul cap. 1
[1] Ci trovavamo presenti quest’anno mentre accadevano
questi fatti. A capotavola sedeva un vecchio cieco, che diceva di aver perso la
vista sedici anni prima. Il re lo serviva. In nostra presenza, gli chiese se
soffrisse molto per la cecità. [2] Il cieco, ignaro che
fosse il re a parlargli, rispose: «Senza l’aiuto della grazia divina, nessuno
desidererebbe continuare a vivere da cieco, tanto è miserabile questa
condizione, specialmente per chi un tempo vedeva la luce». Allora il re disse:
«Vorresti lasciare questa vita?». «No, affatto», rispose lui. E il re: «Se sei
infelice, perché non vuoi liberarti dall’infelicità?». «Non so – rispose il
cieco – se morendo passerei a un’infelicità ancora maggiore, né mi è chiaro dove
andrei a finire». [3] A quel punto uno dei cortigiani
disse: «Non sai forse – gli chiese – che se vivi in modo retto, si apriranno per
te i luoghi destinati ai giusti?». «Io so – rispose il cieco – che esistono tre
luoghi a cui, dopo aver abbandonato il corpo, sono condotte le anime degli
uomini: il cielo accoglie le anime dei giusti; gli inferi quelle dei malvagi; e
quelli che furono malvagi ma, prima di morire, si pentirono del male compiuto,
devono recarsi in purgatorio». [4] Il cortigiano riprese:
«Se credi in queste cose e ti astieni dal peccato, perché non vuoi morire?».
«Credo – rispose il cieco – che a chi muore bene possa toccare una buona sorte.
Ma chi può essere sicuro di morire bene?». Allora il re disse: «Il cieco ragiona
saggiamente: la sua riflessione attinge alla teologia più alta». [5] A quelle parole, il cieco udì che lo avevano chiamato “re” e
chiese chi fosse. Il re rispose: «Sono io, colui che sta parlando con te».
Sul cap. 2
[1] Dall’Ungheria giunsero all’imperatore Sigismondo
quarantamila monete d’oro. Si stava facendo sera, e furono riposte nella camera
reale quando egli si coricò. L’imperatore, mentre rifletteva su come impiegare
quel denaro, non riusciva a prendere sonno. Allora svegliò i suoi camerieri e
disse loro: «Andate subito, convocate i consiglieri e i comandanti militari».
[2] Chiamati nel cuore della notte, i nobili arrivarono
preoccupati e, temendo che fosse accaduto qualcosa di grave, chiesero quale
fosse il motivo di una convocazione così improvvisa. L’imperatore, aperto lo
scrigno, distribuì il denaro tra i presenti: «Andate – disse – ora possiamo
finalmente dormire tranquilli. Ciò che mi toglieva il sonno, ora se ne va con
voi».
Sul cap. 3
[1] In mia presenza, alcuni si chiedevano perché Alfonso,
che si mostrava liberale e munifico verso ogni genere di persona, trascurasse
soltanto gli astronomi. Infatti, a differenza di altre discipline, non si vedono
a corte maestri di quest’arte onorati come gli altri. [2]
Allora uno che sembrava sapere di più disse: «Le stelle – disse – governano e
spingono gli stolti, ma i sapienti dominano gli astri. Perciò è coerente che i
principi stolti onorino gli astrologi, non quelli sapienti; e Alfonso, fra i
sovrani, detiene fama di sapienza». [3] Intervenne allora
un altro: «Pietro da Montalcino, astronomo di non scarsa fama, durante il
Concilio di Costanza, fece una previsione sugli eventi futuri, sostenendo che
Sigismondo sarebbe stato coronato a Roma con grandi onori e che papa Giovanni
XXIII, che aveva convocato il concilio, ne avrebbe ottenuto gloria. [4] Avendo, però, il grande sinodo deposto Giovanni dal
sommo pontificato, e non essendo ancora sceso in Italia Sigismondo pur essendo
trascorsi molti anni, da più parti si levarono ad accusare Pietro di aver detto
una cosa palesemente falsa. Ed egli rispose: “Io dovevo pronunciarmi su due
stolti: Tolomeo stesso non avrebbe potuto predire correttamente la verità su di
loro”».
Sul cap. 4
[1] Fu un motivo non trascurabile di prestigio per Alfonso
che Federico III, dopo esser stato incoronato imperatore a Roma, si recasse a
fargli visita. [2] Rientrato in Germania, interrogato dagli
amici in Italia su ciò che avesse visto di memorabile, Federico rispose:
«Alfonso è il più saggio e magnifico tra tutti i re viventi». [3] Poiché, però, alcuni non approvavano che una dignità maggiore si
recasse da una minore, Federico disse: «Anzi, io sono andato da un superiore.
Benché l’autorità di un re sia inferiore a quella di un imperatore, Alfonso in
sé è più grande di Federico».
Sul cap. 5
[1] Sarebbe un risultato di poco conto aver dato la pace
all’Italia, se poi non la si mantenesse.
Sul cap. 6
[1] La citta di Vienna ha un borgo con una rocca
fortificata, attraverso il quale si passa dall’Austria alla Stiria. Fu affidato
a un vecchio amico di Ernesto I, padre dell’imperatore Federico III. Alcuni
giovani si presentarono più volte a Federico, chiedendo per sé il comando del
luogo, sostenendo che colui che lo governava fosse fiaccato dagli anni e dalle
forze. Federico rispose loro: «Io ho affidato un amico di mio padre alla
fortezza, non la fortezza a un amico».
[2] Quando un duca di Slesia fece testamento, dispose che
fosse costruito un grande edificio, nel quale fossero nutriti fino alla morte,
grazie alle rendite di alcuni terreni destinati a tale scopo, tutti quei cani
usati per la caccia, che, divenuti vecchi o deboli, fossero stati abbandonati
dai loro padroni. E il suo volere fu rispettato.
Sul cap. 7
[1] Giacomo, margravio di Baden, quando apprese di un furto
commesso nei suoi dominî, convocò coloro che avevano subito il danno e ordinò
che ricevessero direttamente dalle sue casse un risarcimento pari al valore,
dichiarato con giuramento, di ciò che avevano perduto. In seguito, ricercò
coloro che avevano commesso il furto e, dopo averli catturati, li fece morire
sulla ruota, che è una forma terribile di supplizio usata in Germania. [2] Così, in breve tempo, rese la sua provincia oltremodo
pacifica. Suo figlio Carlo, giovane di nobile stirpe, sposato con Anna, sorella
dell’imperatore Federico, segue le orme paterne.
Sul cap. 8
[1] Un duca di Opava andò incontro alla moglie, che
proveniva dalla Lituania, e vide al suo seguito un giovane di straordinaria
bellezza e possente corporatura, trasportato su un carro sospeso, adagiato su
cuscini. Pensando che fosse il fratello o un parente della sposa, chiese chi
fosse. [2] Gli risposero che, presso i Lituani, secondo la
loro tradizione, le donne nobili avevano l’abitudine di tenere in casa uno o più
concubini, a seconda delle possibilità del marito, che assolvessero ai doveri
coniugali, qualora quest’ultimo li trascurasse. Proprio per tale motivo quello
era stato condotto, per adempiere a tali incombenze nel caso in cui il duca,
malato o impedito, non potesse soddisfare la moglie. [3] Il
duca avrebbe voluto dare quell’uomo in pasto ai cani, ma, fermato dagli amici,
lo mandò via al più presto in Lituania, provincia nella quale, a quanto si dice,
pochissime mogli si separano dai loro mariti.
Sul cap. 9
[1] «Ha già vinto a sufficienza – diceva l’imperatore
Sigismondo – chi ha messo il nemico in fuga».
Sul cap. 10
[1] Quando chiesero all’imperatore Sigismondo quale uomo
giudicasse degno e adatto a regnare, egli rispose: «Colui che le circostanze
favorevoli non esaltano e quelle avverse non abbattono».
Sul cap. 11
[1] A un borioso cavaliere, che davanti a Sigismondo
disprezzava i magistrati civili e portava in cielo i comandanti militari, quello
replicò: «Taci, Trasone: non avremmo bisogno di eserciti se ogni comunità fosse
governata con moderazione e giustizia dai propri pretori e dagli altri
magistrati».
Sul cap. 12
[1] Forse i Senesi, inconsapevoli, hanno fatto finire un
piccolo ramoscello in un occhio del re. Voglia il cielo che il re non si dolga
di altro se non del dolore e del timore del popolo senese! Invece Joan de Hijar,
che ogni giorno arreca nuovi oltraggi alla nostra città, continua ad accusarla
presso il re. [2] È vero ciò che dice il poeta satirico:
Sul cap. 13
[1] Una lettera di Kaspar Schlick, inviata da Norimberga e
indirizzata ad alcuni Ungheresi, cadde nelle mani dell’imperatore Federico.
Alcuni suggerivano di aprirla, sospettando che si potessero scoprire tracce di
un tradimento. Ma Federico disse loro: «Io considero Kaspar un uomo onesto e
fedele. Se mi sbaglio, preferisco che l’errore si riveli da sé, piuttosto che
venga scoperto dalla mia solerzia».
Sul cap. 14
[1] Non stupisce che Alfonso non creda di poter trovare
sette saggi nel suo regno e nel suo tempo, dal momento che in tutta la Grecia e
in Asia, anzi in tutto il mondo e in ogni epoca, se ne sono a stento contati
altrettanti.
Sul cap. 15
[1] Una volta, l’imperatore Carlo IV entrò nella scuola di
Praga e ascoltò, per quattro ore, le dispute dei professori di arti liberali. Ai
cortigiani, che ne erano infastiditi e gli ricordavano che si stava facendo ora
di cena, rispose: «L’ora si è già fatta per me, non per voi. È questa la mia
cena».
Sul cap. 16
[1] Una volta, davanti a Sigismondo, qualcuno definì beati
gli usurai, che guadagnavano mentre dormivano. Sigismondo gli rispose: «E tu
allora sei uno sventurato, che consumi i tuoi beni restando sveglio».
Sul cap. 17
[1] Se mancano i Trasoni fanfaroni, invano si lamentano i
ruffiani Gnatoni.
Sul cap. 18
[1] Alfonso, a mio avviso, aveva letto quello che un non
oscuro poeta scrisse:
[2] Per questo ha offerto con la sua stessa mano al maestro
frutti e dolci di zucchero.
Sul cap. 19
[1] Giorgio Fistello, sebbene dottore, ricevette
dall’imperatore Sigismondo l’investitura a cavaliere. In seguito si recò al
concilio di Basilea e Sigismondo, trattando di questioni ardue, ordinò che i
dottori andassero da una parte e i cavalieri dall’altra. Poiché Giorgio esitava
nella scelta del gruppo al quale unirsi e, propendeva per i cavalieri, [2] Sigismondo gli disse: «Agisci da stolto, anteponendo la
milizia alle lettere. Io, in un solo giorno, posso fare mille cavalieri, ma in
mille anni non potrei fare un solo dottore».
Sul cap. 20
[1] Vitoldo, duca di Lituania, affermava che la plebe
dovesse essere sottomessa alla legge e la legge al principe. Tanto si mostrò
differente nei costumi e nell’aspetto dai suoi compatrioti, che con un editto
ordinò loro di tagliarsi la barba, conservandola per sé solo, in segno di
sovranità. [2] Ma non ebbe successo, perché i Lituani erano
pronti a perdere la vita piuttosto che la barba. Allora egli stesso si rase il
capo e le guance, minacciando la pena capitale a chiunque, imitando il suo
esempio, si fosse rasato barba o capelli.
Sul cap. 21
[1] «Se fossero scelti con l’elezione e non con la
successione – come dice Isocrate – i principi sarebbero spesso migliori dei
privati cittadini».
Sul cap. 22
[1] Un tale chiese a Tommaso da Sarzana, che in seguito
sarebbe diventato pontefice col nome di Niccolò V, come fosse papa Eugenio IV.
«È facile da capire – rispose. Quale è la sua famiglia, tale è anche il
principe».
Sul cap. 23
[1] Gli Austriaci, che con l’aiuto dei Boemi assediarono a
Neustadt l’imperatore Federico III che tornava dall’Italia, si ritrovarono
infine nella condizione di chiedere pace al vinto, e di versargli ogni anno
seimila pezzi d’oro.
Sul cap. 24
[1] Quando l’Austria fu governata da una donna – poiché la
discendenza maschile si era estinta – gli Ungheresi e i Bavaresi cominciarono a
depredare la provincia. Gli amici le consigliavano di sposare uno dei due
nemici, perché la difendesse dalle offese dell’altro. [2]
Lei rispose: «Non mi sposerò con un nemico. Piuttosto, chiamerò in mio aiuto
Ottocaro di Boemia: arricchito dal mio matrimonio, darà sia ai Bavaresi che agli
Ungheresi ciò che meritano. Non è nella natura delle cose che facciamo del bene
a chi ci fa del male».
Sui capp. 25-26
[1] Mentre l’imperatore Sigismondo si trovava in Italia,
venne a sapere che i padri riuniti a Basilea stavano per deporre papa Eugenio
dal sommo pontificato. Pur soffrendo di gotta, si mise in viaggio e giunse con
tale rapidità che lo si vide nel concilio prima ancora che si sapesse del suo
arrivo. [2] Non gli sembrava tollerabile, infatti, che la
Chiesa, tornata grazie a lui all’unità e alla concordia nel concilio di
Costanza, fosse di nuovo frantumata in quello di Basilea.
Sul cap. 27
[1] Le lettere di condoglianza che hai ricevuto per la
morte di tuo fratello testimoniano il grande affetto che il re nutre per te. Ma
chi può amare il re, se non te, che gli procuri fama anche per le imprese da lui
compiute?
Sul cap. 28
[1] Una volta fu chiesto all’imperatore Federico quale
fosse il bene più grande che potesse capitare a un uomo. Rispose: «Una buona
fine di questa vita».
Sul cap. 29
[1] L’imperatore Sigismondo era solito considerare saggi
coloro che sanno accettare con moderazione gli scherzi, e dotati di ingegno
coloro che sanno farli con prontezza.
Sul cap. 30
[1] L’anno scorso giunse dal duca Alberto d’Austria un
greco che affermava di essere fratello dell’imperatore Costantino, ucciso dai
Turchi. Quando Alberto scoprì che era una spia, intento a riferire ai Turchi i
preparativi in Germania, ordinò che fosse ucciso con la spada.
Sul cap. 31
[1] L’imperatore Carlo IV convocò l’uomo che aveva
complottato per assassinarlo e gli donò mille monete d’oro, affinché potesse
dare in sposa la figlia, già in età da marito, dicendo di provare compassione
per lei, costretta a restare in casa già adulta. [2] L’uomo
ringraziò il re e, andando dai cospiratori, disse loro: «Non sapevo che Carlo
fosse così: adesso che so che è un principe generoso e misericordioso, non
potrei in alcun modo fargli del male».
Sul cap. 32
[1] Alberto imperatore, padre di Ladislao, diceva che la
caccia è un esercizio virile mentre la danza è appropriata alle donne; e che
poteva fare a meno di qualsiasi piacere, ma non della caccia.
Sul cap. 33
[1] Se si deve essere contenti della propria sorte, Alfonso
non può lamentarsi della sua, giacché possiede i regni di tre divinità: quelli
di Plutone in Spagna, di Nettuno in Sicilia e in altre isole, e di Giove in
Italia, benché la sua virtù meriterebbe il dominio su tutto il mondo.
Sul cap. 34
[1] Nessuno che conosca Alfonso dubita che egli sia amante
degli studi e dei libri, poiché ogni suo discorso rivela dottrina. Di recente lo
abbiamo pregato di non lasciare che la Toscana fosse rovinata dalla guerra, egli
che si definisce re di pace. [2] E ha risposto: «Apollo
diede a Cassandra il dono della profezia e della conoscenza del futuro. Ma,
riuniti in consiglio, gli dèi lo giudicarono inopportuno, perché non è
consentito ai mortali conoscere il futuro. Tuttavia, ritenendo nefando revocare
un dono divino, stabilirono che nessuno avrebbe creduto alle profezie di
Cassandra. Allo stesso modo, sebbene mi definisca re di pace, nessuno mi
crede».
Sul cap. 35
[1] Tra coloro che mentono più di tutti, aggiungi pure, se
vuoi, chi molto ha combattuto. [2] Giovanni di Amburgo,
medico non sconosciuto, un giorno, quando l’imperatore Sigismondo ordinò che si
allontanassero tutti quelli che non conoscevano la lingua cumana (poiché aveva
da trattare con i Cumani, popolo dell’Ungheria), non obbedì all’ordine. [3] L’imperatore gli chiese perché non fosse andato via:
«Perché – rispose – hai dato l’ordine di andar via soltanto a chi non conosce il
Cumano, e quell’ordine non mi riguarda. Nessuno è capace quanto me di mentire e
rubare, che è cosa propria dei Cumani».
Sul cap. 36
[1] Anche i dieci comandamenti della legge divina ci sono
affidati e prevedono grande impegno da parte nostra: quando se ne infrange uno,
si infrangono tutti.
Sul cap. 37
[1] Svatopluk, ultimo re dei Moravi, quando seppe che, in
sua assenza, il palazzo reale era bruciato, chiese al messaggero se la cantina
fosse salva. Avuta risposta che tutto era andato distrutto, ma che quella era
rimasta intatta, esclamò: «Allora anche noi siamo salvi e felici!».
Sul cap. 38
[1] «Come gli dèi vogliono essere amati e temuti, così
anche i re – dice Sigismondo –; infatti, non si può amare veramente se non si
teme».
Sul cap. 39
[1] Vorrei che, con l’abilità e l’impegno di Alfonso, non
solo i cittadini, ma anche i soldati corrotti e malvagi divenissero buoni e
corretti. Ma la vita militare, a mio avviso, è un ricettacolo di vizi e non
riceve alcun rimedio dalla virtù.
Sul cap. 40
[1] Direi, in verità, che Alfonso abbia gareggiato e
persino superato tutti in ingegno, dottrina, virtù, abilità e saggezza; sembra
nato per riuscire in qualunque impresa decida di affrontare.
Sul cap. 41
[1] In Austria morì un nobile all’età di novantatré anni,
che aveva condotto la vita tra i piaceri e le lusinghe senza mai una malattia,
né un’ombra di sventura o mestizia. Quando lo riferirono all’imperatore
Federico, egli disse: «Anche da ciò si può ricavare che le anime sono immortali.
Infatti, se Dio governa questo mondo, come insegnano filosofi e teologi, e
nessuno nega che sia giusto, allora esistono altri luoghi in cui le anime
migrano dopo la morte, e lì ciascuno riceve premi o castighi in base a ciò che
hanno fatto. Qui, infatti, né ai buoni vengono date le giuste ricompense, né ai
malvagi vengono inflitte le dovute punizioni».
Sul cap. 42
[1] Se il medico francese rende iniqua la causa cui presta
patrocinio, lo stesso fa il Piccinino, che agisce in maniera ingiusta e
scellerata.
Sul cap. 43
[1] Lo svevo Johann von Rechberg disse: «Se mi fosse data
la scelta di un’occupazione in cui passare la vita, mi piacerebbe inseguire
qualche ricco mercante, come si dice ne esistano a Firenze, puntandogli la
lancia alla schiena, come se lo dovessi catturare». [2]
Così, infatti, ciascuno è tratto dal proprio desiderio, come dice il più grande
dei poeti latini. Ma il dolce ozio e la quiete della vita privata sono preclusi
ai principi, e nemmeno Diocleziano, che si ritirò a coltivare i suoi orti, trovò
il favore della fortuna.
Sul cap. 44
[1] Quando chiesero all’imperatore Federico III chi fossero
per lui i più cari, rispose: «Coloro che mi temono non meno di quanto temono
Dio».
Sul cap. 45
[1] Non mi risulta che Federico III abbia mai giurato, se
non nella città di Aquisgrana, nel territorio dei Belgi, e quando fu incoronato
a Roma; e mantenne costantemente il giuramento. Avendo promesso solennemente di
non alienare in alcun modo i beni dell’impero, e ora l’uno, ora l’altro glieli
chiedeva, preferì negare apparendo avaro, piuttosto che concedere e risultare
spergiuro. [2] Per questo motivo si oppose a lungo alla
richiesta del marchese Borso d’Este di ottenere il ducato di Modena, finché non
gli si dimostrò che la concessione di quel ducato, con un tributo annuale,
sarebbe risultata più un guadagno che un’alienazione, soprattutto considerando
che Modena e Reggio non erano in suo potere. A convincerlo, in particolare,
fummo proprio noi.
Sul cap. 46
[1] Un cittadino di Praga prestò all’imperatore Carlo IV
centomila pezzi d’oro, ricevendone in cambio una ricevuta, e il giorno dopo lo
invitò a pranzo. Estese l’invito anche ad alcuni principi e preparò un banchetto
sontuoso alla maniera boema. [2] Giunti al momento della
frutta e del formaggio (poiché non sono abituati ai dolci di zucchero), fece
portare la ricevuta su un piatto d’oro, destando stupore tra i commensali, che
si chiedevano cosa volesse significare. [3] E disse:
«Cesare, gli altri piatti sono stati gli stessi per te e gli altri nobili, ma
questo è solo per te. Ti dono tutto l’oro che ti ho prestato ieri e ti libero
dal debito».
Sul cap. 47
[1] L’erisipela, il fuoco “sacro”, stava consumando un dito
del piede dell’imperatore Sigismondo, e si temeva che potesse propagarsi. [2] I medici consigliarono di amputare il dito:
l’imperatore acconsentì e rimase immobile e imperturbabile a guardare il bisturi
del chirurgo, come se stessero operando un altro.
Sul cap. 48
[1] In Boemia, dove ci sono molte pianure e pochi
avvallamenti, la fanteria e la cavalleria vengono protette in cerchio da carri.
Dentro questi carri, come se stessero dietro le mura, si dispongono soldati
pronti a colpire il nemico con armi da getto. [2] Quando la
battaglia ha inizio, i carri si dispongono come due ali, che si allungano a
seconda del numero dei soldati e delle necessità del luogo; sul retro e sui
fianchi rimangono coperti, e si combatte sul fronte, mentre i conducenti
avanzano con prudenza, cercando di circondare e chiudere le fila nemiche. Così
facendo, la vittoria è quasi certa, poiché il nemico è colpito da ogni lato. [3] La schiera dei carri è tale da potersi aprire, su
ordine del comandante, quando e dove voglia: sia per la fuga sia per
l’inseguimento dei nemici, se la situazione lo richiede.
Sul cap. 49
[1] Sebbene Alfonso potesse affermare di essere sciolto dal
patto, per colpa di chi lo aveva violato, tuttavia, memore della propria
costanza e dei benefici ricevuti, volle mantenere fede agli accordi stipulati.
[2] Lo stesso sperano ora da lui i Senesi: anche se i
benefici ricevuti dai Senesi non sono comparabili con quelli ricevuti da
Filippo, uguale a quella verso Filippo è la costanza del re verso di loro. [3] Se, d’altra parte, in qualche modo si troverà che i
Senesi hanno violato il patto, cosa che non crediamo, ciò sarà forse dovuto a
ignoranza, non certo a malizia.
Sul cap. 50
[1] Come fosse Alfonso da giovane è ora mostrato dalla sua
età matura. Più di una volta lo abbiamo visto inseguire le fiere col suo veloce
destriero, scagliare lance ora contro cinghiali ora contro cervi, e abbatterli
con la sua stessa mano. [2] Ammiriamo nelle azioni di un
così grande re il vigore più che la prudenza. Non sia mai che la sua vita, in
cui risiede la vita di tanti popoli, venga esposta a pericoli senza grave
necessità.
Sul cap. 51
[1] Questa orazione è degna di un grande re e dello stesso
Alfonso: qui è il dito di Dio. Infatti, queste parole, questi sentimenti, questa
mente non sarebbero possibili se non fossero ispirati dallo Spirito Santo.
Questo discorso è stato pronunciato e portato fino a noi in Germania. Non può
essere negato ciò che è stato detto. [2] Con eleganza il re
ricorda tre grandi benefici ricevuti da Dio: che è stato creato da lui non
bestia, ma un uomo capace di ragionare; non un uomo qualsiasi, ma uomo
cristiano; non un cristiano qualsiasi, ma un re cristiano. [3] La modestia gli ha impedito di rammentare che non è stato reso da
Dio un qualsiasi re, ma il più potente e saggio tra i re d’Europa, cosa che nel
nostro secolo è senza precedenti: re e filosofo. [4] Ma
poiché è onesta e lodevole questa promessa se viene mantenuta, allo stesso modo
è vergognosa e biasimevole se viene trascurata. [5] Per
realizzare tale impresa, è necessaria la pace dell’Etruria, che, essendo
turbata, tiene sospesa tutta l’Italia. Nessuno dubita che il potere e l’arbitrio
di pacificare spettino ad Alfonso. [6] Quindi persuadilo,
Antonio, persuadetelo tutti voi a cui le orecchie del re prestano ascolto a
restituire la pace alla Toscana abbandonando il Piccinino. [7] Così, prese le armi contro i Turchi, potrà difendere e ampliare il
nome cristiano, così come è stato detto da lui.
Sul Trionfo
[1] Quando Alfonso sarà tornato, dopo aver sottomesso i
Turchi liberando Bisanzio, e avrà riportato le spoglie cruente e il capo del
nefando Maometto, quale carro trionfale gli predisporrà l’Italia, quali
ringraziamenti gli offrirà la Chiesa, quali festeggiamenti gli organizzerà tutta
la società cristiana! [2] Verranno a Roma i re del
Settentrione e dell’Occidente per salutare il grande condottiero, salvatore
della repubblica cristiana, che torna vincitore. I cardinali e tutti i vescovi
delle Chiese e i magistrati dell’Urbe, uscendo fuori le mura per un lungo
tratto, gli andranno incontro portando le sacre insegne. [3] I Quiriti gli manterranno le redini e saranno gettati a terra la
porpora e l’ostro perché li calpesti. Le nobili matrone e le vergini gli
lanceranno dai tetti rose e gigli, accomodando sul suo sacro capo corone di
variopinti fiori. [4] Egli stesso dall’alto suo carro
lancerà monete d’oro alla folla, in ogni piazza e in ogni trivio in cui si
fermerà tutto il popolo predisporrà nuovi spettacoli festosi e lo acclamerà
augurando al vincitore vita e gloria. [5] E così trionfando
sarà condotto non nel tempio capitolino del falso Giove, ma nella basilica di
san Pietro, principe degli apostoli. Lì trovando il pontefice, Callisto III,
vero vicario di Cristo e detentore delle chiavi del regno eterno, e ricevendo da
lui l’alta benedizione, lo abbraccerà e lo bacerà come un anziano padre, e
entrerà con lui nei recessi più interni del palazzo, dove discorreranno a lungo
della recente vittoria e delle cose della Spagna. [6]
Allora, Antonio, la tua musa quasi risuonerà dagli alti penetrali: tu comporrai
poemi e Bartolomeo Facio scriverà storie, e donerete immortalità al re mortale.
[7] Anche noi, per conto nostro, se ci sarà consentito
gracchiare come cornacchie tra cigni, troveremo qualcosa da tramandare ai
posteri su un re tanto grande.
notes alpha
notes int