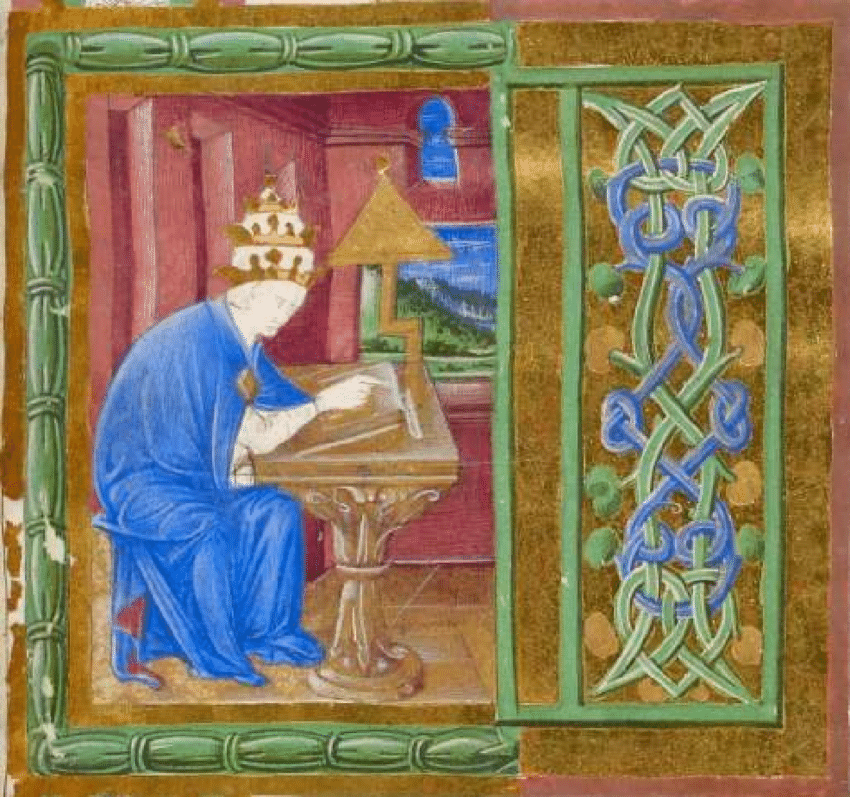
Commento di Enea Silvio Piccolomini agli Alfonsi regis dicta aut facta memoratu digna di Antonio Panormita
date
1456-04-22
title
Enea Silvio vescovo di Siena - Traduzione del Commentario - Libro II
teibody
Sul proemio
[1] Nessuno che conosca Alfonso potrebbe dire che tu,
Antonio, l’abbia adulato. Se tu dici che sono adulatori soltanto coloro che
esaltano al di là del vero le cose fatte e dette dai mortali, la tua operetta,
che pure è scritta in maniera assai elegante, di certo loda il re meno e non più
del dovuto. [2] E non me ne meraviglio: chi mai infatti
potrebbe raccontare in maniera sufficiente le egregie imprese di quel re, che ha
regnato, a giudizio di tutti, in maniera assai sapiente per quarant’anni? [3] Io, per esprimere la mia opinione sul re di cui tratti,
ritengo che sia necessario che chiunque regni, e chiunque regnerà in futuro,
guardi ad Alfonso come a uno specchio di virtù, se vogliono ottenere gloria per
sé e prospera pace per le proprie terre.
Sul cap. 1
[1] Spesso ci furono aspre contese tra i fratelli
dell’Ordine di Santa Maria dei Teutonici e i re della Polonia riguardo ai
confini del regno. Il conflitto è stato risolto ed è stata stipulata una pace
con un trattato giurato e siglato, grazie all’intermediazione dell’imperatore
Sigismondo. [2] Da tre anni a questa parte cinquantacinque
città prussiane hanno iniziato a cospirare tra loro e a prendere empiamente le
armi contro i loro signori, e si ribellano tutte contro i fratelli. [3] Allora Casimiro re di Polonia, affermando che la
Prussia era parte del suo regno, venne a guerra coi fratelli, perdendo
l’occasione di gestire bene la questione. [4] La mitezza di
Alfonso è assai maggiore di quella del re barbaro, ma non minore è la perfidia
usata dal Piccinino contro i Senesi, che, afflitti da una guerra quinquennale,
non ha avuto timore di aggredire con le armi, benché fossero assai amici suoi e
di suo padre.
Sul cap. 2
[1] Ho partecipato a questo matrimonio venendo dall’Austria
come ambasciatore dell’imperatore, e ho assolto all’incarico, sebbene i miei
colleghi Georg von Volckensdorf e Michael von Pfullendorf fossero contrari,
perché ritenevano che la dote promessa non fosse adeguata. [2] L’augusta Eleonora – così infatti la chiamiamo – nipote del re,
quest’anno ha generato un figlio, di nome Cristoforo: bimbo grazioso, assai
simile ad Alfonso nei lineamenti del volto, e volesse il cielo anche nei
costumi!
Sul cap. 3
[1] Ritengo che l’Africano maggiore, che si preoccupò del
pudore di una sola fanciulla, non sia stato abbastanza lodato da Livio, benché
sembri non aver omesso nulla nel celebrare quel fatto. [2]
Alfonso ha preservato intatte tutte le fanciulle e le donne di Marsiglia. E
anche quando ha espugnato quel castello nella regione del Volturno, che si
chiama “Ripa Malerantia” (?), si è comportato con la stessa moderazione. [3] Quali lodi immortali dedicheremo a questo sovrano, se
abbandonerà Piccinino, dal quale le fanciulle e le donne sposate, catturate in
guerra, subiscono oltraggio.
Sul cap. 4
[1] Ratisbona, sul Danubio, in Baviera, è una città grande
e famosa. Qui, quando visitammo l’antica abbazia di Sant’Emmerano, l’abate che
la reggeva ci mostrò un corpo che era lì custodito, che a suo dire era di san
Dionigi Areopagita. [2] Quando gli dicemmo di aver visto
Dionigi a Parigi, ci mostrò una lettera di papa Leone, che testimoniava, se
ricordo bene, che un imperatore, un Enrico, poiché invidiava il re di Francia e
si trovava a Parigi, portò qui queste ossa dopo averle sottratte; il sommo
pontefice chiamava pio il furto dell’imperatore. [3] Noi
possiamo chiamare pia la spoliazione fatta dal re, con la quale san Luigi fu
portato da Marsiglia a Valenza.
Sul cap. 5
[1] Qualche tempo fa in un’ambasceria incontrammo il re, e
si parlò di Filippo duca di Borgogna, perché aveva fatto voto di prendere le
armi contro i Turchi. Lodammo il coraggio del nobilissimo principe e chiedemmo
che cosa avrebbe fatto il re per difendere la religione. [2] Allora egli disse: «Se vivrò, il prossimo anno combatterò i Turchi
con la flotta in Grecia e in Asia. Alfonso, mio nipote da parte di mia sorella,
re del Portogallo, sarà con me, solcheremo il mare con più di quattrocento navi,
manderemo in terra nemica più di cinquantamila soldati: già le armi di ogni tipo
sono pronte. Abbiamo raccolto 75.000 moggi di frumento: abbiamo inviato trenta
navi da carico e nel porto ne hai vista una, che in mare non ce n’è mai stata
una più grande. Il proposito è buono, purché insieme con una vita ci sia anche
la buona salute». [3] Se il re rispetterà la sua promessa,
avrà visto armato tre parti del mondo, e avrà percorso in trionfo l’Europa,
l’Africa e l’Asia. Lo stesso fece un tempo anche Cesare, ma quello combattendo
contro la patria, questi, invece, in difesa sua, cioè della chiesa cattolica,
nella quale tutti con Cristo siamo nati a nuova vita.
Sul cap. 6
[1] Novgorod è la città più grande della Rutenia, ricca
d’oro e argento. Non parlo di quei Ruteni dei quali Lucano dice: «i biondi
ruteni vengono liberati dal lungo presidio militare». È evidente infatti che
quelli abitassero in Gallia. [2] Questi, invece, hanno
sede, oltre la Germania, la Sarmazia e la Lituania, non lontano dalla fonte del
Tanai, fino a cui nessun condottiero romano si è mai spinto. [3] Nel mezzo della piazza principale della città c’è una pietra
quadrata, su cui il re, insieme a qualche altro presente, amministra la
giustizia per il popolo. Ma raramente il potere regio è rimasto per un anno a
uno solo: spesso nello stesso tempo hanno regnato in due o tre. Viene dal
popolo, infatti, colui che si ritiene abbastanza armato di alleanze, e mandando
via il re da quella pietra prende il suo posto, e subito viene acclamato come
re. Anch’egli subisce la stessa sorte, se qualcuno più forte si avventi contro
di lui, desideroso del regno. [4] È mirabile la diversità
dei luoghi: il settentrione disonora i suoi re, il Meridione non onora solo gli
stranieri, ma anche i nemici.
Sul cap. 7
[1] L’imperatore Federico non beve mai vino se non a cena.
E a cena lo beve con grande moderazione, e miscelato con acqua. [2] Una volta, i medici cercavano di convincere Eleonora Augusta, che
mai ne aveva bevuto nella casa paterna, che in Germania, luogo freddo, se avesse
voluto diventare madre, avrebbe dovuto bere vino. [3]
Quando Federico lo seppe, mi chiamò e disse: «Va’ e di’ all’imperatrice che
preferisco una moglie sterile a una che beve vino. Per cui se mi ama, odierà il
vino». [4] A quella frase Eleonora disse: «Anche se per
ordine di mio marito, mi astengo tanto volentieri dal vino, che, se invece
l’imperatore me ne avesse comandato l’uso, avrei preferito morire che
partorire».
Sul cap. 8
[1] C’è l’usanza che i re della Germania, che vengono
eletti imperatori, siano incoronati e unti nel territorio dei Belgi, nella città
di Aquisgrana. [2] Mentre Federico, già eletto, andava lì,
suo fratello Alberto, unite le sue forze con quelle del conte di Celje invase la
Carnia. Cinse d’assedio Labaco, fortezza importante e dotata di grandi difese,
attaccò Krainburg, minacciò Trieste di distruzione qualora non si consegnasse,
mandò altre truppe contro la Carinzia e la Stiria. [3] I
consiglieri più anziani che fra i primi erano stati scelti dal padre Ernesto, e
che erano fedeli, cercarono di persuadere Federico a preoccuparsi più del
patrimonio che dell’impero: «L’impero è un bene comune, e può esser curato in un
secondo momento, ma il patrimonio è un bene proprio destinato a essere
ereditato, e se non lo si protegge ora, è vano desiderare e fare in modo che
passi in eredità». [4] Al contrario Federico decise che del
bene comune dell’impero dovesse occuparsi direttamente, e lasciò quelli
ereditari e privati ai procuratori. E proseguendo sulla strada già intrapresa,
nominò i comandanti che badassero alla patria mentre lui era assente. [5] Quando tornò dall’incoronazione, trovò che il fratello
e i suoi compagni erano stati sconfitti, e convocatolo, immaginando che temesse
l’ospitalità e l’affetto del fratello tradito, lo accolse nuovamente nelle sue
grazie, e, quasi come se non avesse fatto nulla, lo pose nuovamente alla guida
di una parte del regno.
Sul cap. 9
[1] Alberto Magno scrive d’aver visto a Padova una donna
che per quaranta giorni e quaranta notti non mangiò assolutamente nulla, e che
ciò non è contro natura in una donna debole e senza vigore. [2] In verità, quando Niccolò V era papa, dai più lontani territori
della Francia venne a Roma un prete, il quale affermava che da quattro anni non
aveva mai mangiato nulla e che aveva assaggiato qualcosa solo quando era stato
invitato dai vescovi, ritenendo un pericolo per il suo digiuno il fatto che
qualcuno lo invitasse per molti giorni. [3] Costui, mentre
era a Siena, disse al nostro Leonardo Benvolenti che si sarebbe recato presso la
curia romana, e che lì avrebbe sopportato il peccato senza morire. [4] Quando giunse a Roma, vi restò molti giorni, suscitò
l’ammirazione delle folle, come se fosse santo e caro a Dio. Infine, preso e
battuto con le verghe, fu cacciato: si sospettava infatti qualche
stregoneria.
Sul cap. 10
[1] I conti di Württemberg in Germania hanno il dominio di
quasi tutta la Svevia. Benché non abbiano né il titolo né l’appellativo di
principi, tuttavia sono più potenti di molti altri, e sono ritenuti insolenti e
disonesti, perché non rispettano il seggio di Roma e non si sottomettono alla
sua autorità. [2] Un nobile, che per lungo tempo era stato
al loro seguito, dopo essersene allontanato, fuggì presso la corte
dell’imperatore: a quel tempo regnava Enrico VII, nonno di Carlo IV e padre di
Sigismondo. [3] Questo nobile, al cospetto dell’imperatore,
accusava ogni giorno i conti, chiamandoli ora ribelli, ora ladri, nemici
dell’impero, spregiatori della Chiesa. A lui Enrico disse: «Taci,
approfittatore: non mi fido di te né quando lodi quelli che riteniamo pessimi,
né quando parli male di loro, di cui tu stesso una volta eri seguace».
Sul cap. 11
[1] L’ambasceria di Ludovico Pontano e Niccolò Siculo
sarebbe stata ottima e degna di un principe così grande, se gli animi non
fossero stati discordi e dominati dall’invidia, in maniera inutile sia al re sia
al concilio. [2] Anche io ero a Basilea e so che il sinodo
non era meno occupato a riconciliare gli ambasciatori del re che a riportare i
Boemi al consenso della Chiesa Cattolica. [3] Ma poiché
stiamo parlando di ambasciatori, non sembra inopportuno ricordare ciò che
abbiamo sentito a proposito di quelli di Lubecca da Kaspar Schlick, il quale fu
presente: Lubecca si trova nel luogo in cui un tempo si stabilirono i Cimbri.
[4] Questi che furono inviati come ambasciatori presso
l’imperatore Sigismondo, sebbene analfabeti, erano tuttavia circospetti, cauti e
pronti ad affrontare le situazioni impreviste. Il più anziano, piegando le
ginocchia per inginocchiarsi come si conviene, emise aria con turpe crepitio.
[5] Tutti scoppiarono a ridere, ma lui, voltando la
testa all’indietro, rivolse queste parole alla parte oscena del suo corpo: «Sta’
zitto, tu, amico mio. La città di Lubecca ha mandato me, non te, come
ambasciatore per parlare con l’imperatore»!
Sul cap. 12
[1] Antonio, cardinale di San Marco e nipote di papa
Eugenio IV, raccolse una quantità incredibile di monete di antichi imperatori e
principi: anch’egli fu amante dell’antichità. [2] Alfonso,
mentre ci trovavamo da lui a Pozzuoli, disse di aver trovato una moneta d’oro di
Nerone, in cui il nefando imperatore usurpava la stessa lode che innalza al
cielo il divo Augusto: «Chiusi il tempio che gli antichi dedicarono a Giano»; il
sapientissimo re condannava lo stolto principe, che rivendicava per sé una
gloria falsa. [3] Non c’è motivo dunque, Antonio, perché tu
o io dovremmo sperare di ottenere con la menzogna la benevolenza di un re così
grande.
Sul cap. 13
[1] Non mi meraviglio che Bartolomeo Facio, che scrive le
gesta del re, abbia imitato nello stile Giulio Cesare, dal momento che i suoi
commentari piacciono così tanto al sovrano, ma sono degne le cose che piacciono.
[2] In verità dicono che Svitrigalo, duca di Lituania,
non si spostasse mai dalla patria, preferendo piuttosto tenersi informato per
mezzo di altri, o che portasse con sé il libro sull’arte culinaria che aveva
composto con grande accuratezza, come aveva fatto Apicio, cultore di cibi
squisiti. [3] Una cena da lui non durava meno di sei ore,
ed era solito far portare non meno di trenta portate. Ma spessissimo, mentre si
leggeva, ne venivano portate novanta o cento. Così mangiano i re nordici
dell’occidente.
Sul cap. 14
[1] Le cose che Platone prescrive in maniera alternativa,
Alfonso le compie insieme, in quanto è letterato e ama i letterati. Ma è uccello
raro sulla terra: infatti nei tempi nostri tutti i re sembrano quasi Norcini,
che cacciano i “letteruti” (così chiamano i letterati) dalle assemblee.
Sul cap. 15
[1] Dicono che Venceslao re di Boemia fosse solito ripetere
spesso conversando con i suoi nobili: «Io, se la sorte mi concedesse di essere
presente al saccheggio delle città d’Italia, concederei ai soldati di far
bottino di tutto, terrei per me soltanto il vino come spoglia. Se qualcuno
entrerà nella cantina senza il mio ordine, sarà colpito con la spada». [2] I principi elettori lo deposero come inetto e indegno
dell’impero, e, nominato Roberto il Bavaro al suo posto, tutte le città tedesche
passarono dalla sua parte, eccetto Norimberga, che giurò fedeltà a Venceslao.
[3] Questi poiché rispettavano il vincolo del
giuramento, ma allo stesso tempo temevano il potere del Bavaro, inviarono
ambasciatori a Venceslao, chiedendo di scioglierli dal giuramento, e offrirono
per questa cosa, se necessario, ventimila monete d’oro. [4]
Il re, ascoltati gli ambasciatori, dichiarò sciolti gli abitanti di Norimberga,
purché gli mandassero quattro carri di vino che si chiama Baccaracense, che è
ritenuto il migliore tra quelli del Reno.
Sul cap. 16
[1] Allo stesso principe, che – come si è detto prima –
tolse la mosca dal bicchiere, un tale chiese venti monete d’oro per la sua unica
figlia, perché potesse sposarsi, dal momento che egli non sapeva dove trovare la
dote. [2] Poiché la richiesta gli fu negata, preparò una
lettera commendatizia per un re vicino, che scrisse un uomo mite e nostro amico,
e la inviò al principe perché la firmasse. [3] Il principe
gli disse: «Dove hai preso la carta?». «Dal tuo armadio», rispose. Allora il
principe disse: «Così dunque mi derubate di tutto. Se in questo modo
scialacquiamo i nostri beni, arriveremo presto a mendicare. Abbiamo speso male
questa giornata».
Sul cap. 17
[1] L’Italia si vergogni dei suoi sacerdoti, che neppure
una volta hanno letto i vangeli. Tra i Taboriti troveresti a stento una
donnicciola che non sappia rispondere sia sul nuovo che sull’antico
testamento.
Sul cap. 18
[1] Se, per salvare un’unica galea, nella quale sarebbero
potuti morire duecento uomini o poco più, il re decise di correre un così grande
pericolo, cosa sarebbe disposto a fare per la navicella di san Pietro, con la
quale, se non scamperà alla tempesta dei Turchi, la comunità cristiana rischia
di perire?
Sul cap. 19
[1] Vitoldo, duca di Lituania, faceva dilaniare dagli orsi
che nutriva in patria i colpevoli di lesa maestà, cui faceva cucire addosso
pelli d’orso. [2] Gli abitanti della provincia temevano a
tal punto la sua crudeltà – perché non voglio chiamarla severità – che quando
talvolta a due o più diceva: «Andatevi a impiccare», nessuno disobbediva al
comando, e addirittura si sentì qualcuno che esortava gli altri complici
dicendo: «Andiamoci in fretta per non suscitare l’ira del signore».
Sul cap. 20
[1] Federico III imperatore, vinti in guerra e catturati
con la forza gli abitanti di Kőszeg in Ungheria, mandò al patibolo 80 uomini che
erano stati responsabili di sommosse e ribellioni, e concesse al resto della
popolazione vita, libertà e ricchezze.
Sul cap. 21
[1] A Napoli, seguivamo Alfonso dall’ospedale di Santa
Maria al castello reale, quando un uomo molto anziano, riverente nel volto e nei
gesti, lo salutò. [2] Il re rivolgendosi a noi disse: «Così
mentre assediavo questa città venne verso di me nell’accampamento e mi esortò a
stare di buon animo. Era infatti, all’incirca, il primo giugno e stavo per
espugnare la città: predisse che di lì a poco si sarebbe svolta una battaglia
incerta, e che in essa sarebbe stato catturato il comandante dell’esercito, e mi
indusse a non partecipare a quella battaglia. [3] La prima
parte della profezia si compì, e il 2 giugno ricondussi Napoli in mio potere.
Poi, le nostre truppe e quelle di Antonio Caldora vennero nel territorio di
Capua; tra i nostri c’era incertezza sull’opportunità di attaccare battaglia,
poiché temevano per la mia vita. E quando ciò mi fu riferito dissi: “Dunque vi
mette paura questa cosa, che deve invece darvi coraggio e audacia!”. Indossai
subito l’elmo, e dato il segnale di battaglia mi volsi contro il nemico, ne
ruppi le schiere, vinsi, combattei e feci prigioniero Antonio. Non mi atterrì né
una predizione, né il timoroso consiglio degli amici».
Sul cap. 22
[1] Cesare fu superiore ad Alfonso solo nel nuoto, dal
momento che egli ad Alessandria, con la barca quasi affondata, raggiunse a nuoto
la flotta. È evidente che i Batavi erano tanto abili in ciò, da attraversare
armati il Reno, che è il loro fiume più grande. [2] Oggi
posseggono quel luogo gli uomini di Maastricht, uomini bellicosi e più esperti
nel nuoto rispetto agli altri che abitano sul Reno.
Sul cap. 23
[1] Le donne preservate a Biccari mostrano che l’animo del
re è diverso da quello mostrato dall’esercito di Piccinino nel violare le donne
sposate e vergini ad Orbetello.
Sul cap. 24
[1] Alfonso non disdegnò di esporsi nelle battaglie che
condusse fra cristiani. Non c’è motivo dunque di dubitare che egli prenderà le
armi contro i Turchi, e che parteciperà a una spedizione tanto gloriosa.
Sul cap. 25
[1] Alberto margravio di Brandeburgo, che non a caso
chiamano l’Achille teutonico, dopo che ebbe saputo che da Norimberga, con cui
era in guerra, erano stati mandati 800 cavalieri e 6000 fanti nel suo territorio
per far bottino, fece appostare 200 arcieri tra gli arbusti vicino al fiume,
nell’unico punto in cui poteva essere guadato da cavalieri e fanti, perché,
lasciati passare i cavalieri, impedissero ai fanti di passare. [2] Egli stesso con 600 cavalieri si nascose nel bosco vicino, e dopo
aver lasciato passare i cavalieri nemici, uscì allo scoperto. Entrambe le
schiere rimasero ferme a una distanza di quasi trecento passi non senza
trepidazione, poi il margravio con due compagni, con la lancia in resta si
avventò contro il nemico. [3] Accorsero altrettanti
valorosi uomini contro di lui da parte nemica. Il margravio trafisse e abbatté
quel cavaliere che gli si era fatto incontro. Ma mentre i suoi compagni erano
sopraffatti da quelli con cui avevano combattuto, egli, da solo, si lanciò in
mezzo alla torma nemica, ora ne uccise uno, ora un altro, e ne fece non poca
strage, finché non giunse alle insegne. [4] Lì furono
sfoderate contro di lui cento spade, e benché non riuscissero a ferirlo di punta
dopo averlo circondato, ignari di chi fosse a osare tanto, lo colpirono di
taglio. [5] Egli afferrato con entrambe le braccia il
vessillo, disse: «Giammai, se non ora, potrei morire più onorevolmente!». Mentre
da solo compiva queste cose, il resto dell’esercito accorse in suo aiuto, e,
volti in fuga i nemici, trovò il comandante esanime, pesto e ferito vicino al
vessillo. I nemici furono uccisi o catturati, e solo in pochi riuscirono a
fuggire, mentre i fanti, bloccati presso il fiume, non poterono essere impiegati
in battaglia. [6] Queste cose ci riferirono Alberto stesso
e altri valorosi uomini durante il viaggio da Neustadt in Austria a Vienna.
Alberto è degno di avere una fama quasi come quella d’Alfonso.
Sul cap. 26
[1] Quando l’imperatore Federico negò al fratello Alberto –
che più otteneva e più voleva – ciò che gli veniva chiesto, e costui gli disse
che era indegno che un fratello fosse abbandonato dal fratello: «Io non
abbandono te, fratello, ma i tuoi cortigiani – disse – a cui ho dato ciò che ho
concesso a te».
Sul cap. 27
[1] Raccontano che un prete di Monte Calvo, che si trova
vicino a Vienna, fosse solito, dopo aver bevuto fino a mezzogiorno, dormire fino
al tramonto, e, una volta sveglio, andare in chiesa, preparare l’altare,
indossare gli abiti talari e richiamare il popolo con le campane, poiché aveva
deciso di celebrare messa. [2] Quando gli venne chiesto
perché assolvesse così tardi agli uffici divini, si dice che, voltosi ad
Occidente, scambiandolo per l’Oriente, abbia risposto: «Piuttosto mi chiedo se
sia lecito celebrare di mattina così presto, prima che sia sorto il sole.
Infatti, benché risplenda l’aurora, non possiamo dire che sia giorno finché sul
nostro orizzonte non risplenda il sole».
Sul cap. 28
[1] Ludovico duca di Baviera, che ho visto a Basilea e a
Norimberga, deforme per una grossa scrofola e per la gobba, ma abile nel parlare
e coraggioso, si mosse empiamente in armi contro il padre Ludovico. E non ebbe
pudore di perseguitare il venerando anziano con un duro e miserabile assedio.
[2] Ma colpito da una febbre violentissima, morì
anzitempo, prima di poter mettere in catene suo padre. Nessuno impunemente può
commettere crudeltà contro l’autorità paterna, e non sono longevi sulla terra
quelli che disonorano i genitori. [3] Infame il nostro
tempo, che ha visto non solo questo Ludovico, ma anche Ludovico delfino di
Francia e Alfonso primogenito di Castiglia armati contro i padri.
Sul cap. 29
[1] Ulrico, conte di Celje, in questo anno desiderava
parlare con Giovanni Hunyadi che governava il regno d’Ungheria, ed egli non
rifiutò, purché venisse da lui. Quello, allora, rispose: «Io, principe nato da
un principe e da antico lignaggio, non verrò da te, che sei uomo nuovo e
diventato nobile da poco». [2] Giovanni gli rispose: «Non
mi paragono ai tuoi avi, ma a te, e benché non sia inferiore neppure a loro, io,
che sono diventato nobile combattendo per la religione cristiana, ho reso la mia
discendenza più luminosa di quanto abbiano fatto i tuoi avi. E mentre con te la
contea di Celje si estingue con disonore, con me si innalza gloriosamente la
discendenza di Bistrica».
Sul cap. 30
[1] Federico, margravio di Brandeburgo, che aveva condotto
al comando del legato apostolico Giuliano un esercito forte e numeroso contro i
Boemi, per fare testamento chiamò a sé i quattro figli, Giovanni, Federico,
Alberto e l’altro Federico. [2] E si dice che abbia parlato
a Giovanni, che era il maggiore, in maniera ferma: «Io per primo ottenni per la
nostra famiglia la dignità di eleggere l’imperatore, quando ero non più d’un
servo dell’imperatore Sigismondo. Ora l’estrema ora mi reclama, e temo che un
onore tanto grande nella nostra famiglia si svilisca. Come vedo, l’unica tua
preoccupazione è per la quiete e la tranquillità. Nella dignità elettorale non
troverai nulla se non affanno e fatica continua, per cui, se con la tua volontà
posso farlo, per testamento lascerò il marchesato di Brandeburgo, che ha la
facoltà di eleggere l’imperatore, al secondogenito Federico, che ti succede per
età, e che è più pronto e più resistente alle fatiche di quanto lo sembri tu. A
te lascio il Vogtland, ad Alberto quanto possiedo per diritto franco, e
all’altro Federico parte del Meissen». [3] Giovanni gli
rispose: «Padre, già prima di oggi avevo capito che Federico ti fosse molto più
caro di me, poiché lo lodavi più spesso, sopportandolo di malanimo. Ora cambio
parere, e ti amo e ti rispetto, padre, che secondo la tua ultima volontà lasci a
me la tranquillità e a lui l’impegno». [4] Da questo
Giovanni è nata la moglie di Ludovico marchese di Mantova, che risplende tra le
donne del nostro tempo per bellezza e costumi.
Sul cap. 31
[1] Giovanni, figlio di Rodolfo re di Boemia, irritato con
suo zio paterno Alberto imperatore dei Romani perché, avendogli chiesto una
parte dell’Austria, non era stato subito accontentato, poiché non riusciva a
trovare qualcuno che per favore o a pagamento gli promettesse di uccidere un
imperatore tanto importante, si recò lui stesso dallo zio, fingendo di essergli
amico, e dopo essere riuscito ad attraversare il Reno in Elvezia, lo colpì col
pugnale mentre era distratto. [2] Subito preso da
pentimento si recò ad Avignone dal papa Clemente V, per essere assolto. Quello
rimandò l’autore di un delitto tanto grande da Enrico VII, imperatore dei
Romani. L’imperatore ordinò che il colpevole facesse penitenza a Pisa presso il
monastero degli Agostiniani, e lì Giovanni morì e fu sepolto. [3] Io, quando ero stato inviato dall’imperatore Federico presso
l’augusta Eleonora, visitai la sua tomba.
Sul cap. 32
[1] Ascoltai Bernardino da Siena, che papa Niccolò V ha
annoverato tra i santi, che raccontava questa favola in una predica: una
nobildonna prese da un contadino delle ciliegie appena raccolte, e, entrata
nella sua camera da letto, le divorò famelicamente quasi tutte ingurgitandole a
piene mani con tutti i noccioli. Poi avendo riportato all’uomo quelle che erano
rimaste, invece di farne un sol boccone come prima, le mordeva tre o quattro
volte. [2] Gli chiese poi in che modo si dovessero mangiare
le ciliegie in campagna. A lei il contadino, che l’aveva vista mentre le
divorava attraverso una piccola fessura, disse: «Nel modo in cui le hai mangiate
poco fa quando eri sola nella tua stanza». La donna arrossì. [3] Bernardino diceva che vivono bene quelli che fanno ogni cosa come
fosse manifesta agli dei e agli uomini.
Sul cap. 33
[1] Alberto di Baviera si innamorò perdutamente di una
fanciulla custode dei bagni, e, per ottenere ciò che voleva, le promise le
nozze. [2] Una volta, mentre si tessevano le lodi delle
donne dinanzi a lui, e nessuno la nominava, chiamò invidiosi, e apprezzatori
ignari di ogni bellezza, i cortigiani che omettevano sua moglie. [3] Ernesto, padre di Alberto, la fece gettare nel Danubio a
Straubing: delitto certamente indegno per colpa del figlio, quello che una
fanciulla innocente venisse uccisa. [4] Dice il vero
Strabone, che chiamò la legge comodità dei potenti.
Sul cap. 34
[1] In Inghilterra, quando i prelati o i baroni cenano, i
servi svolgono il loro servizio in ginocchio. [2] In
Germania non si spendono per nulla in adulazione né con l’imperatore né con un
re, e i servi mangiano nello stesso momento in cui il signore mangia, rimanendo
solo in due o tre a mettere il vino e i cibi in tavola.
Sul cap. 35
[1] Ho sentito spesso dire all’imperatore Federico che tra
coloro che aveva beneficato, pochissimi gli erano riconoscenti, e che ciò era
causato dai suoi doni, che avevano reso infedeli quelli che erano fedeli.
Sul cap. 36
[1] Tutte le città della Germania superiore decisero di
aiutare Norimberga contro Alberto margravio di Brandeburgo, che aveva loro
dichiarato guerra. E mentre si preparava un esercito numeroso, un tale chiese
come mai preparassero in armi un popolo così tanto contro un solo principe e
certo non ricchissimo. [2] A costui rispose uno dei nobili
della città: «Stolto! Le forze e le ricchezze di tutti i principi tedeschi sono
guadagnate dall’astuzia e dalla forza di Alberto». [3] E
questa frase non fu falsa: Alberto portò dalla sua parte diciassette principi, e
costrinse le città, fiaccate da molte rovine, a chiedere la pace.
Sul cap. 37
[1] Enrico conte di Gorizia, poiché quello che aveva le
chiavi della cantina non c’era, dato che aveva sete iniziò a prendere a calci la
porta, e dato che Febo della Torre, che era stato allevato con lui, lo biasimò e
lo pregò di smettere di distruggere i battenti, gli disse: «Taci. Non sei tu a
tormentarmi, ma la sete».
Sul cap. 38
[1] Sarebbe un dovere non liberale, ma pio e santo
riscattare i Cristiani catturati dai Turchi. Cosa che spererei possa accadere,
se Alfonso, come promette, conducesse contro Maometto la flotta e le truppe di
terra fossero condotte contro i Turchi.
Sul cap. 39
[1] A un campagnolo, che aveva portato al mercato di
Neustadt in Austria del grano da vendere, fu rubato uno dei due cavalli dalla
biga mentre si era allontanato per andare in taverna. [2]
La denuncia del furto fu riportata all’imperatore Federico. All’accusatore fu
ordinato di fare il nome del ladro, ma egli rispose che aveva subito il furto
nella città regia, ma di ignorare chi fosse il ladro. [3]
Mentre i consiglieri stavano a pensare su chi si potesse sospettare, Federico
disse: «È strano che quest’uomo non abbia perso anche l’altro cavallo: in questa
città ci sono tanti cavalieri che necessitano di cavallo?» [4] Allora il campagnolo disse: «Imperatore, l’altra è una cavalla,
che non serve a nulla a coloro che combattono». «Ma allora – rispose
l’imperatore – qualcuno le salga in sella e corra dappertutto nei vicoli della
città! Il cavallo sottratto si trova in qualche stalla, e non appena sentirà la
cavalla del suo giogo, subito nitrirà». Il campagnolo obbedì e in questo modo
recuperò ciò che era suo, e il ladro fu punito. [5] È
necessario che coloro che sono a capo della giustizia, siano non soltanto
giusti, ma anche prudenti e assai acuti. [6] Il boemo
Zisca, che guidò l’esercito della comunità dei Taboriti, dopo che ebbe distrutto
una città in Austria, e non vi trovò armenti – che infatti erano stati condotti
sull’isola fortificata che sta in mezzo al Danubio – avendo preso dalle campagne
immediatamente vicine due giovenche e altrettanti maiali, ordinò che in
prossimità dell’isola fossero bastonati fino a quando le vacche e i maiali,
udendo il muggito e il grugnito, passassero sull’altra riva. [7] Catturati questi animali riuscì a fare non piccolo bottino, e così
dimostrò che le azioni militari si devono condurre con ingegno non inferiore
alla forza.
Sul cap. 40
[1] All’arcivescovo Giacomo di Treviri, principe elettore,
uomo operoso e di grande ingegno, ma assai avido e attento a innalzare la
potenza della sua chiesa, due anni dopo che giunse dall’imperatore Federico a
Neustadt, poiché supplicando chiedeva sempre più cose, e incalzava chiedendone
moltissime, l’imperatore disse: «Se non smetti di chiedere, io inizierò a dire
di no».
Sul cap. 41
[1] Teodorico vescovo di Colonia, di certo il primo per
saggezza e autorità tra gli elettori imperiali, all’imperatore Sigismondo che
chiedeva in che modo potesse ottenere la felicità, rispose: «La ricerchi invano
tra i mortali». Quando gli chiese di nuovo come volgere a quella celeste, gli
disse: «Per la retta via». [2] E poiché per la terza volta
gli chiedeva cosa fare per incamminarsi sulla retta via, gli rispose: «Se
disporrai e vivrai la tua vita così da fare ciò che hai promesso, finché un
calcolo, la podagra, o un’altra malattia ti opprimerà acutamente».
Sul cap. 42
[1] Avrei voluto sentire cosa disse Andrea, quando tornò a
Palermo dopo aver incontrato il re. Io quando andrò via di qui, se qualcuno mi
chiederà cosa ho visto degno di esser ricordato a Napoli, risponderò anzitutto
quattro cose. [2] Napoli, città splendida per l’aria
salubre, per il porto, per le chiese, le case, i campi, seconda a nessuno in
Italia per cavalli e armi. Il castello regio, che chiamano nuovo, che si innalza
sugli altri di tutta Europa per grandezza, splendore, arte e fortificazione. E
quella nave che può superare tutte le altre che a memoria d’uomo abbiano solcato
i mari. E per far quadrare il conto, aggiungerò di re Alfonso. [3] E come quinta cosa, se qualcuno volesse ascoltare, parlerei di
quel sacro sangue di san Gennaro, che mostrano ora solido, ora liquido, benché
sia stato versato nel nome di Cristo milleduecento anni prima. [4] Infine aggiungerò i resti di Baia, Cuma e Pozzuoli, che sembrano
uguagliare quelli di Roma.
Sul cap. 43
[1] Quando ad Alberto duca d’Austria, che alla morte
dell’imperatore Sigismondo, di cui era genero, prese il regno d’Ungheria e
Boemia insieme all’Impero Romano, un principe disse che era necessario esser
protetti dall’amore dei sudditi, e che a ciò bastasse solo l’innocenza, il
suocero rispose: «Anche una guardia fidata evita gli infortuni».
Sul cap. 44
[1] Sotto il pontificato di papa Niccolò V fiorirono gli
studi letterari, di cui egli era amante. Sotto il nuovo Callisto il diritto
viene innalzato al cielo. Alfonso col suo esempio ha reso i suoi cortigiani
amanti delle lettere e della caccia.
Sul cap. 45
[1] Morto Alberto padre di Ladislao, i Boemi e gli
Ungheresi chiesero come loro re l’imperatore Federico. Egli rispose loro: «Possa
star lontana da me la scelleratezza di portar via l’eredità paterna a mio
cugino». [2] Anche Federico margravio di Brandeburgo e
principe elettore, chiamato dai Polacchi come re, disse: «Avete Casimiro che è
fratello del re morto, e chiedete a lui, che la legge di successione ha reso re.
Se per caso egli non volesse regnare tornate da me». [3]
Anche Alberto duca di Baviera rifiutò il regno di Boemia che gli era stato
offerto, per non escludere Ladislao. Abbiamo visto questa moderazione ai nostri
tempi tra i principi tedeschi e l’abbiamo ritenuta degna di memoria.
Sul cap. 46
[1] Il conte Burcardo rispose al nostro collega Leonardo
Benvoglienti che chiedeva con che diritto Piccinino avesse invaso il territorio
di Siena: «Per diritto militare. In guerra, infatti, è lecito attaccare tutti
quelli cui non siamo vincolati». Ma questa legge è una grande ingiustizia. È
opportuno che il re, il quale, per suo ordine, non vuole che i governatori delle
provincie non si curino di nulla oltre che dell’amministrazione e della
giustizia, si separi del tutto da Piccinino, eversore delle buone leggi e di
ogni giustizia.
Sul cap. 47
[1] Silvestro vescovo di Chiemsee diceva che sempre
sarebbero rimasti nelle attività pubbliche quei nobili che avevano ricercato la
corte per oziare, a meno che non ne fossero allontanati per pericolo di
morte.
Sul cap. 48
[1] Sigismondo diede non pochi schiaffi a uno che lo lodava
smisuratamente e che lo definiva simile agli dei, e a quello che gli chiedeva:
«Perché mi percuoti?», rispose: «Tu perché mi stuzzichi?»
Sul cap. 49
[1] Amedeo duca di Savoia, che il clero riunito a Basilea,
dopo aver deposto dal pontificato Eugenio IV, elesse al suo posto chiamandolo
papa Felice V, offrì in matrimonio a Federico imperatore dei Romani una figlia
che stava in casa, giovane e vedova e di grande bellezza, con una dote di
duecentomila monete d’oro, se, lasciato Eugenio, lo avesse chiamato successore
di Pietro. [2] L’imperatore inorridì e non volle affatto
deturpare i sacramenti della chiesa con il suo matrimonio. Anzi rivolgendosi ai
suoi disse: «Alcuni son soliti vendere le cariche pontificali: costui le compri
pure, qualora trovi un venditore».
Sul cap. 50
[1] Quando i porporati accusarono presso Sigismondo il
popolo tedesco di maldicenza, poiché dappertutto parlavano male del loro
principe, l’imperatore sorridendo rispose: «Forse a voi sembra grave che quelli
parlino male, quando noi agiamo male?».
Sul cap. 51
[1] Quando un ladro disse che era cittadino di Buda, e che
perciò riteneva di dover essere risparmiato, disse Sigismondo: «Anche la mia
mano, se putrida, va tagliata».
Sul cap. 52
[1] Regi devono essere considerati non solo gli abitanti
del regno, ma tutti i popoli che si trovi nella possibilità di salvare. Dunque,
o re, devi proteggere i Senesi non meno dei Napoletani.
Sul cap. 53
[1] L’imperatore Federico diceva: «A Dio, quando prego,
chiedo misericordia, non giustizia. Perché non dovrei essere clemente e
misericorde nei confronti dei sudditi?».
Sul cap. 54
[1] L’imperatore Federico diceva che i principi
inflessibili e poco miti dovessero temere molto la morte. Infatti, come da vivi
si sono posti più in alto degli altri, così da morti troveranno per sé giudici
simili.
Sul cap. 55
[1] Tutti evitano di praticare le arti che non hanno
appreso; nessuno rifiuta di comandare, che è l’arte più difficile tra tutte le
arti.
Sul cap. 56
[1]
[2] Quando fu chiesto all’imperatore Rodolfo, che per primo
diede alla sua famiglia l’impero in Austria, perché ciò accadesse: «Non c’è da
meravigliarsi – disse – che si ritengano stolti quelli che non sanno governare,
ma nessuno ritiene se stesso stolto».
Sul cap. 57
[1] Michele di Pfullendorf, il segretario dell’imperatore
Federico che è sepolto nella mia chiesa a Siena, diceva che tra tutte le cose la
più sorprendente è che gli animali privi di ragione non dovrebbero porsi al di
sopra del re, a meno che non siano superiori agli altri per virtù. Gli uomini
che si ritengono razionali, spesso hanno obbedito a principi che erano più
stolti dei bruti quadrupedi.
Sul cap. 58
[1] Alfonso aveva mandato a Parigi due fanciulli a
studiare. Ci trovavamo da lui i Castel Nuovo, quando Joan Soler gli portò una
loro lettera. Lo vedemmo esultare molto, quando seppe, leggendo, che facevano
progressi.
Sul cap. 59
[1] Bartolomeo Capra vescovo di Milano, affermava che per
questa ragione egli cercasse sacerdoti belli d’aspetto: perché gli animi turpi
abitano corpi turpi, e che assai raramente si ritrova malvagità in uno dal
bell’aspetto.
Sul cap. 60
[1] Quando fu chiesto all’imperatore Sigismondo perché
tanto di frequente nelle città libere si commettesse peculato, rispose: «Perché
le cariche senza profitto vengono affidate ai cittadini, ma il popolo vuole il
guadagno».
Sul cap. 61
[1] Disse l’imperatore Federico: «Non posso compiacermi
degli stolti, né essere amico dei superbi».
Sul cap. 62
[1] Stavamo portando da Pisa a Siena l’imperatrice Eleonora
per ordine dell’imperatore Federico. Il giorno prima delle Ceneri, quando la
gente è solita fare pazzie, presso San Miniato al Tedesco, in territorio di
Firenze, ci imbattemmo in una danza di contadine, che spesso ballando si
scoprivano le ginocchia e mostravano le gambe. E quando l’imperatrice lo vide,
disse: «Andiamo, questo è uno spettacolo di meretrici, non di vergini».
Sul cap. 63
[1] Dopo aver sconfitto Kőszeg in Ungheria, l’imperatore
Federico disse: «Una grande opera è stata compiuta. Ora ne resta una più grande:
dobbiamo vincere noi stessi, e mettere un freno al desiderio di vendetta e di
preda».
Sul cap. 64
[1] Disse l’imperatore Rodolfo: «Talvolta mi sono pentito
d’esser stato severo e poco mite, mai invece di esser stato mite e
clemente».
Sul cap. 65
[1] L’imperatore Sigismondo diceva che i re in terra
potevano esser beati se, una volta esclusi i superbi, avessero accolto a corte i
cultori di mitezza e di misericordia.
Sul cap. 66
[1] Bernardo, padre monastico, sommo maestro di astinenza,
quando talvolta, in presenza di ospiti, cenava oltre misura, e i discepoli lo
ritenevano una sregolatezza, rispondeva: «Non sono io a bere e a mangiare, ma la
carità».
Sul cap. 67
[1] Alfonso non solo chiamò presso di sé uomini illustri
nelle armi o nelle lettere, del cui consiglio si serviva nelle faccende
d’amministrazione, e con loro riuscì a provvedere a molte cose, ma dalla sua
corte come da una officina di uomini eccellenti, fece uscire ottimi comandanti
di truppe e venerabili uomini di chiesa. [2] Infatti, anche
Callisto III, che ora regge la cattedra del pontificato, dalla scuola di Alfonso
papa Eugenio elevò alla carica di cardinale.
notes alpha
notes int